Lo specialista Pablo Arrondo parla in questo articolo lo stress da una prospettiva fisiologica. In particolare, spiega il sistema di difesa per affrontare stimoli avversi, nel quale si verificano risposte fisiologiche che producono cambiamenti nei meccanismi neuronali.
Ipotalamo, depressione, recettori dei glucocorticoidi, cortisolo, corticosterone, surrenali
Nel corso dell’evoluzione, gli animali hanno sviluppato un sistema di difesa per affrontare stimoli avversi, nel quale si verificano una serie di risposte fisiologiche che producono cambiamenti nei meccanismi neuronali ed endocrini che permettono all’organismo di mantenersi in omeostasi (McEwen, 2008).
Si verificano principalmente due meccanismi fisiologici:
- Da un lato, il sistema simpatico adrenomedullare (SAM) risponde molto rapidamente agli stressor, poiché coinvolge il sistema nervoso simpatico e la midollare surrenale. Un esempio della sua capacità di risposta è il raddoppio della frequenza cardiaca dopo lo stimolo, preparando l’organismo a una situazione minacciosa. In questa risposta allo stressor, si attivano i neuroni del nucleo paraventricolare dell’ipotalamo, del tratto solitario e del locus coeruleus del tronco encefalico. I neuroni di queste strutture rilasciano adrenalina e noradrenalina (catecolamine) che raggiungono le cellule degli organi attivati dal sistema simpatico, intensificando ad esempio le funzioni adattative di lotta o fuga (Guyton & Hall, 2005).
- D’altro canto, il asse Ipotalamo-Ippofisi-Surrene (HPA), in cui i neuroni del nucleo paraventricolare dell’ipotalamo hanno assoni che proiettano verso l’eminenza media, dove viene secreta l’ormone liberatore di corticotropina (CHR). Questo, a sua volta, stimola la secrezione da parte dell’adenoipofisi (ipofisi) dell’ormone adrenocorticotropo (ACTH). L’ACTH ha come bersaglio la corteccia delle ghiandole surrenali (fascicolata e reticolare), situate vicino ai reni, che secernono glucocorticoidi negli animali (Morén, 2007) e cortisolo negli esseri umani (Gómez & Escobar, 2006). Questo ormone fornisce agli organi del corpo maggiore energia, mantenendo adeguati i livelli di glucosio.
Successivamente, il cortisolo prodotto nella corteccia surrenale esercita un feedback negativo sul sistema inibendo l’ipotalamo e l’ipofisi legandosi ai glucorecettori presenti nel cervello (McEwen, Weiss & Schwartz, 1968).
I glucocorticoidi (cortisolo o corticosterone) si legano anche ai recettori dei mineralcorticoidi (MR), che sono più presenti nelle strutture limbiche del cervello rispetto ai recettori dei glucocorticoidi (GR). Questi ultimi, invece, sono più diffusi in altre aree del sistema nervoso centrale (Chao, Choo & McEwen, 1989; Van Eekelen, Jiang, De Kloet & Bohn, 1988).
I MR hanno una maggiore capacità di legame con la corticosterone o il cortisolo, approssimativamente 10 volte superiore a quella dei recettori dei glucocorticoidi (GR) (Reul & De Kloet, 1987). Perciò, in condizioni normali, i primi sono già attivi, e quando viene rilasciata una grande quantità di cortisolo, esso attiva i GR che si occupano di inibire la sintesi di CHR e ACTH.
Il sistema torna allo stato basale, pronto per un’altra situazione di stress. Quando gli stimoli stressanti si prolungano nel tempo, il meccanismo di feedback negativo smette di funzionare adeguatamente e può scatenare un disturbo fisico o psicologico (Jimenez, Gutierrez, Dominguez & Contreras, 2008).
Lo stress e la depressione maggiore
Lo stress e la depressione maggiore condividono molte caratteristiche, poiché le strutture e le vie cerebrali coinvolte in ciascun processo sono simili (Gold e Chrousos, 1999). Inoltre, è stato osservato che alcuni pazienti depressi aumentano le dimensioni delle ghiandole surrenali (Montes, 2004), che sono implicate nella produzione di glucocorticoidi dovuti allo stress, così come negli animali sperimentali (Grippo, Francis, Beltz & Johnson, 2005; Rygula, Abumaria, Domenici, Hiemke & Fuchs, 2005).
È importante sapere quali fattori correlati allo stress siano indicatori di vulnerabilità allo sviluppo di malattie. Ad esempio, gli eventi stressanti durante l’infanzia possono effettivamente generare malattie nella fase adulta (McCrory, De Brito & Viding, 2012; Bremme & Vermetten, 2001; Heim & Binder, 2012).
Inoltre, il modo in cui si affronta ciascuna situazione può essere un fattore determinante nello sviluppo di future malattie. Così, ad esempio, una strategia passiva è un fattore di rischio per la depressione maggiore e una strategia attiva lo è per le malattie cardiovascolari (Koolhaas, 2008).

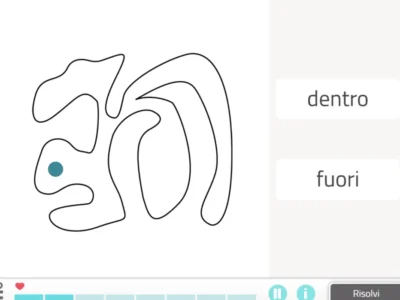






Lascia un commento