La neuropsicologa Lidia García Pérez spiega le nuove proposte di stimolazione sensoriale per i disturbi della coscienza.
I programmi di stimolazione sensoriale hanno una lunga storia d’uso nella neuroriabilitazione, essendo una delle opzioni terapeutiche più utilizzate nell’approccio ai disturbi globali della coscienza dopo un grave danno cerebrale[1].
L’idea su cui si basano è che gli ambienti arricchiti promuovono la plasticità neuronale e, pertanto, il recupero di questi pazienti[2, 1]. Tuttavia, diverse revisioni sistematiche recenti[3, 4, 5, 6], inclusa una pubblicata da La Collaborazione Cochrane[3], concludono che manca ancora evidenza affidabile che supporti o controlli l’efficacia della stimolazione sensoriale nei pazienti con disturbi globali della coscienza (stati di coma, vegetativo o di veglia senza risposta, minima coscienza).
D’altra parte, negli ultimi anni ci sono stati progressi nella conoscenza del cervello in generale e dei disturbi della coscienza in particolare, e sono emersi nuovi paradigmi e nozioni teoriche che rendono necessario valutare se le caratteristiche principali del metodo di stimolazione sensoriale siano ancora adeguate in base a quanto conosciamo oggi.
Recentemente, Frontiers in Human Neuroscience ha pubblicato un lavoro[2] in cui gli autori rivedono le caratteristiche principali della stimolazione sensoriale, valutando quali sono obsolete e quali no, e proponendo alcuni cambiamenti che sono in linea con le conoscenze e le prospettive teoriche attuali.
Nel post di oggi parlo brevemente della stimolazione sensoriale e della concezione attuale di coscienza e dei disturbi della coscienza, per poi passare a un riassunto di detto lavoro.
Concezione attuale della coscienza e dei disturbi globali della coscienza.
Tradizionalmente, lo stato normale di coscienza e i disturbi della coscienza (stati di coma, vegetativo o veglia senza risposta e minima coscienza) sono stati definiti in base a due componenti:
- Arousal (il livello di allerta o attivazione, “essere coscienti”) che si definisce come la capacità di svegliarsi e mantenere i cicli sonno-veglia.
- Il awareness (contenuto della coscienza o “essere consapevoli”) che si definisce come capacità di integrare i diversi stimoli sensoriali in una conoscenza che ci consente di renderci conto di noi stessi e di ciò che accade intorno a noi[7].
Così, lo stato di coma si caratterizza per essere una condizione normalmente transitoria, in cui il paziente non presenta né arousal né awareness e rimane con gli occhi chiusi senza rispondere alla stimolazione né comunicare.
Nello stato vegetativo o di veglia senza risposta il paziente mostra gli occhi aperti, riflettendo la preservazione del sistema reticolare di attivazione ascendente e quindi l’arousal. Tuttavia, non essendo in grado di generare un comportamento determinato, si ritiene che manchi loro la coscienza o awareness.
Infine, nello stato di minima coscienza i pazienti sono in grado di generare comportamenti che, sebbene variabili, sono riproducibili, perciò si considera che essi posseggano awareness oltre all’arousal [8].
Tuttavia, negli ultimi anni i meccanismi di coscienza sono stati associati a nuove concezioni quali la informazione distribuita[9], aree corticali che interagiscono e la connettività cerebrale [10, 11]. Attualmente, la coscienza è vista come la capacità di un sistema di integrare informazioni che sembra dipendere dalla capacità del cervello di sostenere schemi complessi di attività distribuiti tra le aree corticali che interagiscono [2].
In linea con questa prospettiva, i disturbi della coscienza sono stati recentemente ridefiniti come un sindrome di disconnessione, in cui un’interruzione funzionale e/o strutturale a livello di un mesocircuito cortico-striato-pallido-talamo-corticale influisce sulla riemersione della capacità di risposta consapevole [12], opinione supportata da numerose linee di evidenza recenti [1].
Sotto questo paradigma conexionista entrano in gioco nuove nozioni teoriche e, pertanto, è opportuno considerare anche nuovi fattori nel definire i trattamenti più idonei per i pazienti con disturbi della coscienza, sia a livello globale, per quanto riguarda una possibile integrazione delle diverse approcci di trattamento esistenti (neuromodulazione, trattamento farmacologico, stimolazione sensoriale, ecc.), sia a livello particolare per ciascuno di essi, nel caso in esame, relativamente ai programmi di stimolazione sensoriale.
Prova NeuronUP gratis per 7 giorni
Potrai collaborare con le nostre attività, progettare sedute o fare riabilitazione a distanza.
Che cos’è la stimolazione sensoriale: fondamento e caratteristiche principali.
La stimolazione sensoriale per pazienti con disturbi della coscienza è una metodologia indirizzata a promuovere l’arousal e la risposta comportamentale di questi pazienti mediante la applicazione di stimoli ambientali [13], in modo che fornendo gradualmente informazioni sensoriali al loro sistema nervoso si induca il paziente a compiere qualche azione, al livello in cui egli possa rispondere [7].
A tal fine, si fa uso di odori e sapori diversi di intensità medio-alta, suoni verbali e non verbali (tra questi ultimi, rumore bianco o musica), stimoli visivi (oggetti, fotografie) e stimoli tattili (contatto fisico, percezione del proprio corpo, oggetti di diverse texture, spostamento di un oggetto, ecc.)[7].
Anche se sono state adottate diverse versioni e procedure all’interno di questo metodo, esse coincidono invariabilmente nelle seguenti caratteristiche [2]:
- Gli stimoli presentati sono semplici,
- con un’intensità da media a elevata,
- possono avere un contenuto autobiografico e/o emotivo,
- vengono presentati in modo ripetuto e frequente,
- vengono somministrati attraverso molteplici canali sensoriali.
La stimolazione sensoriale è una metodologia poco invasiva, che non comporta pericoli, economica e facile da applicare, ragioni per cui continua a essere un metodo di riabilitazione attraente [14]. Tuttavia, come menzionato sopra, la sua base teorica non è stata definita chiaramente in passato e, in generale, esistono risultati contraddittori sulla sua efficacia che rendono necessaria un’ulteriore ricerca sui suoi procedimenti con una metodologia più controllata [3, 4, 5, 6], nonché l’aggiornamento delle sue caratteristiche in funzione delle conoscenze attuali [2].
Nuove proposte nella stimolazione sensoriale per i disturbi della coscienza
Abbate et al.[2] hanno valutato le caratteristiche principali del metodo di stimolazione standard e propongono una proposta aggiornata che include alcune modifiche. Le loro proposte sono:
Stimolazione complessa, includendo stimoli strutturati e significativi
Come osservano gli autori, nei protocolli standard di stimolazione sensoriale si usano di solito stimoli semplici e spesso privi di significato (descontestualizzati), seguendo l’ipotesi implicita che i pazienti con disturbi della coscienza abbiano capacità di attenzione ridotte e che, pertanto, gli stimoli semplici siano più adeguati in quanto più facili da elaborare cognitivamente.
Tuttavia, studi recenti indicano che questi pazienti possono partecipare a compiti strutturati e potrebbero aver conservato risposte complesse, il che suggerisce che mantengono “isole di funzionamento cognitivo di alto livello” preservate.
Sulla base di questi riscontri, gli autori propongono che l’obiettivo dei futuri protocolli sia la stimolazione di quelle funzioni cognitive isolate, ma preservate di alto livello, per le quali gli stimoli complessi potrebbero risultare più efficaci rispetto a quelli semplici.
Evitare l’alta frequenza e la ripetizione degli stimoli
Generalmente, i programmi standard consistono nel presentare una stimolazione semplice, ripetitiva, frequente e di intensità da media a elevata.
Gli autori sottolineano che tale procedura è in contrasto con gli obiettivi di stimolazione dei processi cognitivi, poiché potrebbe prodursi una risposta di abituazione, che, come ricordano, consiste in una diminuzione della risposta neuronale e comportamentale derivante dalla stimolazione ripetuta.
Pertanto, propongono di evitare sia la ripetizione sia l’alta frequenza di presentazione degli stimoli, poiché anche una stimolazione più frequente comporta una diminuzione della risposta più rapida e/o più pronunciata.
Somministrare stimoli di intensità adeguata, occasionalmente intervallati con stimoli di alta intensità
Per quanto riguarda l’intensità, il vantaggio della stimolazione intensa (stimoli ad inizio brusco e ad alta energia) è che stimola facilmente l’attenzione; tuttavia, dati i risultati contrastanti emersi dalla ricerca a riguardo, gli autori si chiedono se la stimolazione intensa possa anch’essa indurre abituazione o meno, per cui propongono di intervallare stimolazione di intensità adeguata (quindi, a mio avviso, di intensità naturale) con stimoli intensi in modo occasionale.
Stimolazione multisensoriale integrata e simultanea
Un tipico protocollo di stimolazione sensoriale di solito implica la stimolazione di molteplici modalità sensoriali diverse (visiva, uditiva, tattile, ecc.), motivo per cui viene definita multimodale. Tuttavia, gli stimoli utilizzati sono di un’unica modalità, stimolando ciascun canale sensoriale separatamente. In tal modo, la stimolazione praticata non è realmente multisensoriale, poiché vengono somministrati in serie diversi stimoli unimodali.
Come indicano gli autori, la ricerca recente sull’integrazione multisensoriale evidenzia che l’attenzione tende a orientarsi più facilmente verso gli input o ingressi sensoriali che possiedono proprietà multisensoriali e che ciò avviene automaticamente.
Inoltre, fanno riferimento a diversi studi neurofisiologici che suggeriscono che l’elaborazione corticale cerebrale è multisensoriale non solo nelle cortecce associative, ma anche nelle cortecce primarie. Perciò, concludono che gli stimoli multisensoriali sono un’opzione migliore rispetto a quelli unimodali, poiché potenzialmente sono più in grado di catturare i processi attentivi e le funzioni cognitive di alto livello preservate in modo isolato nei pazienti con disturbi globali della coscienza.
Stimoli emotivi
Basandosi su studi pubblicati dal 2005, gli autori concludono che l’uso di stimoli emotivi rimane un’opzione preziosa nelle procedure di stimolazione sensoriale.
Nello specifico, riportano risultati su:
- Il accesso prioritario che l’informazione emotiva ha alla cognizione (attenzione e coscienza)
- la sua migliore ritenzione rispetto alle informazioni senza contenuto emotivo,
- la sua influenza sulle rappresentazioni di alto livello come pensieri e azioni,
- sulla possibile facilitazione dell’integrazione del processamento emotivo con processi cognitivi top-down quali l’attenzione, il contesto del compito e la coscienza.
Stimoli con contenuto autobiografico
Gli stimoli con contenuto autobiografico hanno anch’essi il supporto della ricerca recente per considerarli come opzioni adeguate, poiché, in base alle evidenze citate, promuoverebbero l’integrazione che favorisce la coscienza e avrebbero gli stessi vantaggi del processamento emotivo.
In particolare, i ricordi autobiografici attivano una ampia rete di regioni cerebrali e con ciò diversi sistemi di memoria (episodica, semantica personale) e altri processi (immaginazione visiva, autoriferimento, processi emotivi e di controllo esecutivo), il che suggerisce che questi ricordi facilitano l’integrazione delle informazioni.
È stata inoltre proposta una stretta relazione tra la memoria episodica e un alto livello di coscienza (livello autonoetico) come meccanismo che facilita la coscienza.
Stimolare le risposte chiedendo al paziente di compiere azioni
I protocolli standard di stimolazione sensoriale di solito si limitano a stimolare la percezione, o al massimo la memoria e il processamento emotivo associato ad alcuni stimoli.
In base a studi di neuroimmagine funzionale e neurofisiologici che di recente hanno segnalato che un sottogruppo di pazienti con disturbi della coscienza mostra “risposte nascoste”, gli autori suggeriscono che possa essere vantaggioso chiedere al paziente durante la sessione di eseguire azioni complesse, in modo che, oltre a stimolare il suo arousal, stimoliamo anche comportamenti definiti, mediante ripetizioni ed esercizi.
Sebbene le evidenze indichino che praticamente ogni esperienza (inclusa la percezione) ha il potenziale di modificare il cervello e produrre cambiamenti duraturi, questa plasticità in molti casi è specifica. Pertanto, la stimolazione limitata alla percezione potrebbe indurre cambiamenti ristretti, mentre ci si aspetterebbero risultati maggiori stimolando sia il processamento in entrata o percettivo, sia quello in uscita o d’azione.
Inoltre, è stata proposta una teoria della rappresentazione dell’azione che considera l’azione come il nucleo delle reti rappresentazionali più importanti (per cui, gli autori suggeriscono che l’approccio alle azioni, oltre a quello alle percezioni, potrebbe favorire l’integrazione).
Azioni naturalistiche e dinamiche in un contesto reale o virtuale
I contesti in cui di solito si svolgono le sessioni di stimolazione (clinici) tendono ad essere artificiali, inducendo il terapeuta a utilizzare stimoli semplici e ripetitivi e ad amministrarli in modo controllato, similmente a quanto si farebbe in laboratorio. Inoltre, si tratta di stimoli privi di rilevanza emotiva e di contenuto autobiografico, e diretti a stimolare solo il processamento in entrata.
Gli autori propongono di realizzare azioni naturalistiche e dinamiche in contesti più adeguati, che consentano di introdurre i pazienti in situazioni che coinvolgano copioni comportamentali specifici (ad esempio, fare colazione con la famiglia).
I compiti naturalistici, sia in situazioni reali che virtuali, comportano stimoli complessi e richiedono sia il processamento in entrata (percezione) sia quello in uscita (azione). Perciò, secondo gli autori, sono contesti ideali per l’introduzione di stimoli emotivi e autobiografici.
Pertanto, le possibili direzioni per una stimolazione sensoriale aggiornata indicate da questi autori si basano fondamentalmente su concetti di stimolazione complessa. Ciò implica l’utilizzo di stimoli strutturati e significativi, somministrati simultaneamente attraverso molteplici canali sensoriali in modo integrato. Allo stesso modo, comprende l’approccio al processamento cognitivo sia in entrata sia in uscita, e l’esecuzione di azioni dinamiche e naturalistiche che eviterebbero stimolazioni ripetitive e frequenti prive di significato. Includerebbero inoltre stimolazioni con intensità adeguata, che verrebbero occasionalmente intercalate con stimoli intensi.
Tutte queste azioni manterrebbero gli aspetti validi di rilevanza emotiva e rilevanza autobiografica.
Bibliografia
- Schnakers C & Monti MM (2017). Disorders of consciousnessafterseverebraininjury: therapeuticoptions. CurrOpinNeurol, 30(6): 573-579. doi: 10.1097/WCO.0000000000000495.
- Abbate C, Trimarchi PD, Basile I, Mazzucchi A, Devalle G (2014). Sensorystimulationforpatientswithdisorders of consciousness: fromstimulation to rehabilitation. Frontiers in Human Neuroscience, 8: 616. doi:10.3389/fnhum.2014.00616.
- Lombardi FFL, Taricco M, De Tanti A, Telaro E,Liberati A (2002). Sensorystimulationforbraininjuredindividuals in coma orvegetativestate (Review). Cochrane Database of SystematicReviews, CD001427. DOI: 10.1002/14651858.CD001427.
- Lancioni GE, Bosco A, Olivetti Belardinelli M, Singh N N, O’Reilly M F and Sigafoos J(2010). Anoverview of interventionoptionsforpromotingadaptivebehavior of personwithacquiredbraininjury and minimallyconsciousstate. Dev. Disabil. 31, 1121–1134. doi: 10.1016/j.ridd.2010.06.019.
- Klingshirn H, Grill E, Bender A, Strobl R, Mittrach R, Braitmayer K, Müller M. (2015). Quality of evidence of rehabilitationinterventions in long-termcareforpeoplewithseveredisorders of consciousnessafterbraininjury: A systematicreview. J RehabilMed.47(7):577-85. doi: 10.2340/16501977-1983.
- Padilla R &Domina A (2016). Effectiveness of SensoryStimulation to Improve Arousal and Alertness of People in a Coma orPersistentVegetativeStateAfterTraumaticBrainInjury: A SystematicReview. Am J OccupTher., 70(3):7003180030p1-8. doi: 10.5014/ajot.2016.021022.
- Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) (2011). Cuadernos FEDACE sobre daño cerebral adquirido: síndrome de vigilia sin respuesta y de mínima conciencia. Madrid: FEDACE.
- Gibson RM, Owen AM, Cruse D (2016). Brain-computer interfaces forpatientswithdisorders of consciousness. Progress in BrainResearch,228, pp. 241-291.
- Tononi G. (2004). Aninformationintegrationtheory of consciousness. BMC Neurosci. 5:42. doi: 10.1186/1471-2202-5-4.
- Laureys S (2005). The neural correlate of (un)awareness: lessonsfromthevegetativestate. Sci. 9, 556–559. doi: 10.1016/j.tics.2005.10.010.
- Rosanova, M., Gosseries, O., Casarotto, S., Boly, M., Casali, A. G., Bruno, M.-A., et al. (2012). Recovery of cortical effectiveconnectivity and recovery of consciousness in vegetativepatients. Brain 135, 1308–1320. doi: 10.1093/brain/awr340
- Schiff ND. (2010). Recovery of consciousnessafterbraininjury: a mesocircuithypothesis. TrendsNeurosci., 33:1-9
- Giacino JT(1996). Sensorystimulation: theoreticalperspectives and theevidenceforeffectiveness. Neurorehabilitation 6, 69–78. doi: 10.3233/NRE1996-6108.
- Abbate&Mazzucchi (2011). “La riabilitazioneneuropsicologicadeidisturbiglobalidellacoscienza,” in La RiabilitazioneNeuropsicologica, ed A. Mazzucchi (Milano: MassonElsevier),389–406.





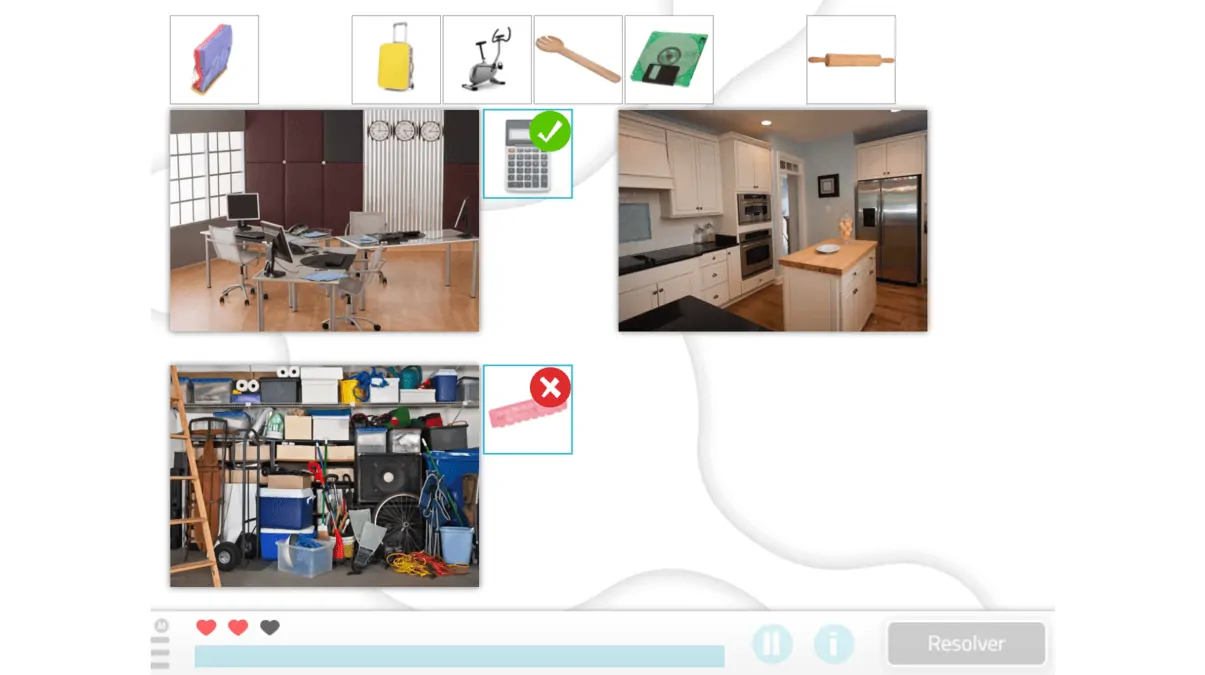

 Differenze tra ADHD e ASD: Comprendere due disturbi dello sviluppo neurologico
Differenze tra ADHD e ASD: Comprendere due disturbi dello sviluppo neurologico

Lascia un commento