Sai come nascono le fobie? Riusciresti a identificare se ne soffri? O come eliminarle? La neuropsicologa Cintia Martos ci spiega le principali caratteristiche delle fobie e la relazione tra cervello e fobie.
Cosa sono le fobie?
Una fobia si definisce come una paura intensa che compare immediatamente davanti a un oggetto o a una situazione concreta. Le fobie più comuni solitamente riguardano certi animali o insetti. Inoltre, tra le fobie più diffuse ci sono la paura di volare, delle altezze, delle iniezioni o del sangue. Tuttavia, le situazioni e gli oggetti fobici possono essere infinitamente vari.
Anche se la paura dovrebbe avere lo scopo di proteggerci, nelle fobie si trasforma in qualcosa di disadattativo che può arrivare a costituire un ostacolo per le nostre attività quotidiane. Come le paure, anche le fobie si apprendono, accompagnandosi a rapidi cambiamenti plastici nel cervello. Allo stesso modo, questi cambiamenti sono molto resistenti all’estinzione, poiché l’organismo interpreta che la sua sopravvivenza sarebbe in pericolo se la paura cessasse.
Caratteristiche: segnali che soffri di una fobia
Secondo i criteri diagnostici del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali V (DSM-V), le fobie presentano le seguenti caratteristiche:
- L’oggetto o la situazione che scatena la paura viene solitamente evitato attivamente. La persona si rifiuta di rimanere nella situazione temuta, cosa che può causare un deterioramento della qualità della vita, soprattutto se lo stimolo fobico può essere presente nella vita quotidiana.
- La paura o l’ansia è persistente, durando più di sei mesi.
- Se ci si riflette, l’ansia sperimentata è sproporzionata rispetto al pericolo reale rappresentato da quella situazione o oggetto.
- La paura, l’ansia o l’evitamento provocano un importante disagio o finiscono per influenzare gli ambiti di funzionamento della persona (come quello sociale o lavorativo).
Come nascono le fobie?
La paura e l’ansia hanno un’origine biologica, ossia sono risposte evolutive il cui scopo è rilevare o anticipare un pericolo. La paura è accompagnata da cambiamenti autonomici ed endocrini che preparano l’organismo a reagire al pericolo (combattendo, fuggendo o immobilizzandosi) con l’obiettivo di aumentare la probabilità di sopravvivenza.
Tuttavia, questa paura può risultare disadattativa, come avviene nel caso delle fobie. Oltre a non contribuire in modo significativo alla sopravvivenza, può generare difficoltà nella nostra vita quotidiana.
Gli organismi possiedono paure innate, ossia che possono emergere fin dalla nascita senza essere apprese tramite esperienza, come stimoli dolorosi o molto intensi (ad esempio, rumori forti). Man mano che gli esseri viventi conoscono il mondo, si rendono conto dell’esistenza di situazioni avversive e pericolose. Progressivamente imparano quali sono e dove si presentano abitualmente per evitarle o affrontarle efficacemente. Questa paura appresa rimane adattativa, ma può diventare disadattativa, come avviene nelle fobie e nei disturbi d’ansia.
Condizionamento pavloviano
Quando uno stimolo neutro, come un suono, viene associato a uno stimolo avversivo, lo stimolo neutro — che inizialmente non aveva significato — finisce per provocare paura da solo nel soggetto. Per esempio, quando un suono è accompagnato da una scossa elettrica. Ciò avviene perché la connessione suono-scossa elettrica si immagazzina rapidamente nella memoria, facendo comparire la risposta di paura non appena si ascolta il suono. L’apprendimento della paura si spiega spesso con questo tipo di condizionamento.
Il condizionamento della paura è un processo molto rapido e potente. Anzi, una singola esposizione simultanea di due stimoli di questo tipo può già consolidare l’apprendimento della paura nella memoria.
Teoria della predisposizione biologica
Secondo la Teoria della predisposizione biologica di Martin Seligman, le fobie insorgono da un insieme di associazioni biologiche che l’organismo è evolutivamente predisposto ad apprendere in modo rapido e persistente. In questo modo, il condizionamento verso stimoli di paura rilevanti — come serpenti, ragni, espressioni facciali di paura o rabbia o volti di altri gruppi sociali — risulta più resistente all’estinzione e può consolidarsi senza che l’individuo ne sia consapevole.
Una volta appresa, la paura condizionata può perdurare per tutta la vita. Tuttavia, le risposte di paura possono indebolirsi o essere eliminate grazie a esperienze che dimostrino che quello stimolo non predice più il pericolo.
Relazione tra cervello e fobie
Il processo di acquisizione delle fobie ha delle basi cerebrali. Il nostro cervello è plastico, cioè cambia in base alle nostre abitudini e ai nostri apprendimenti. Quando si verifica il condizionamento della paura, questo è accompagnato da cambiamenti molecolari e strutturali in specifiche cellule nervose.
Strutture cerebrali nella relazione tra cervello e fobie
Amigdala
La principale struttura cerebrale implicata nelle fobie è l’amigdala. Questa regione è comunemente associata alle emozioni, soprattutto alla paura. In essa si stabiliscono le connessioni tra lo stimolo temuto e il contesto che lo accompagna. Inoltre, innesca risposte di attivazione dell’organismo affinché reagisca rapidamente al pericolo.
È un’area cerebrale piccola a forma di mandorla situata all’interno del nostro cervello e fa parte del sistema limbico (sistema emozionale). L’amigdala è una struttura complessa che contiene diversi gruppi di neuroni, ciascuno con funzioni specifiche e interconnessi tra loro.
L’amigdala laterale
Riceve tutte le informazioni sensoriali (visive, uditive, tattili…) e le collega allo stimolo temuto. Inoltre, è stato dimostrato che queste informazioni possono viaggiare attraverso “due vie” sensoriali distinte. In primo luogo, la via talamica, la più breve, che trasmette rapidamente informazioni in modo impreciso. In secondo luogo, la via corticale, dove si produce una rappresentazione più complessa, elaborata e conscia dello stimolo esterno.
In quest’area avvengono i principali cambiamenti sinaptici nell’apprendimento della fobia. Le connessioni neuronali si rafforzano man mano che si instaura il condizionamento della paura.
Il nucleo centrale dell’amigdala
Si occupa di inviare le informazioni elaborate ad aree del tronco encefalico che controllano l’espressione delle risposte di paura, come l’immobilizzazione. In questo modo si attivano i sistemi adrenergico, serotoninergico, dopaminergico e colinergico, che provocano cambiamenti endocrini e autonomici tipici della paura.
Il nucleo basale
Riceve informazioni dall’ippocampo, dalla corteccia entorinale e dalle aree di associazione polimodale. Inoltre, quest’area dell’amigdala immagazzina informazioni sul contesto ambientale in cui si è verificata la minaccia. Per questo motivo proviamo paura nei luoghi in cui in passato è comparso uno stimolo fobico, anche se in quel momento non è presente.
Le cellule intercalate
Gruppo di neuroni GABAergici, cioè inibitori. Possono inibire le risposte di paura “bloccando” il flusso di informazioni dall’amigdala laterale e basale verso il nucleo centrale. Ad esempio, in caso di falso allarme.
Studi interessanti sul cervello e le fobie
Mediante studi sugli animali è stato dimostrato che se si stimola il nucleo centrale dell’amigdala si possono innescare diverse componenti della risposta di paura. Invece, se quest’area viene lesionata, la paura verso stimoli condizionati diminuisce e il soggetto non può acquisire nuove paure.
D’altra parte, se la lesione interessa l’ippocampo — la zona che invia informazioni all’amigdala sul luogo in cui è comparso lo stimolo temuto — scomparirebbe solo la paura del contesto, ma non quella dello stimolo.
Per quanto riguarda l’attività cerebrale nelle fobie, in uno studio di Schienle& cols. (2005) sono state riscontrate differenze tra le persone con fobia dei ragni e quelle senza mentre osservavano immagini di questi insetti e altre neutrali. I fobici mostravano maggiore attivazione nell’amigdala, nella corteccia di associazione visiva, nell’ippocampo destro e nella corteccia prefrontale dorsolaterale destra. Quest’ultima è associata all’elaborazione delle emozioni negative. Si è osservata anche attività nell’area motoria supplementare (collegata alla preparazione e alla motivazione al movimento). Inoltre, quanto più sgradevole era considerata un’immagine, tanto maggiore risultava l’attività nell’amigdala.
Un metanalisi pubblicato nel 2012 ha evidenziato l’iperattività nell’insula (oltre che nell’amigdala) di soggetti fobici. Entrambe le strutture sono correlate a risposte emotive negative.
Eliminare una fobia tenendo conto della relazione tra cervello e fobie
Una fobia può essere estinta mediante esposizioni ripetute allo stimolo temuto in un contesto neutro o sicuro. A poco a poco si impara che l’oggetto o l’evento fobico non rappresenta più pericolo. Questa è la base delle terapie di esposizione efficaci.
Tutto ciò ha un fondamento cerebrale, poiché si è dimostrato che l’estinzione della paura è correlata all’interazione tra amigdala, ippocampo e corteccia prefrontale mediale.
Riferimenti
- Associazione Americana di Psichiatria. (2013). Guida di consultazione dei criteri diagnostici del DSM-5.
- Dbiec, J., &LeDoux, J. (2009). The amygdala and the neural pathways of fear. In Post-Traumatic Stress Disorder (pp. 23-38). Humana Press.
- Etkin, A., &Wager, T. D. (2007). Functional Neuroimaging of Anxiety: A Meta-Analysis of Emotional Processing in PTSD, Social Anxiety Disorder, and Specific Phobia. The American Journal of Psychiatry, 164(10), 1476–1488. http://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07030504
- LaBar, K. S., &Cabeza, R. (2006). Cognitive neuroscience of emotional memory. Nature Reviews Neuroscience, 7(1), 54.
- Sánchez Navarro, J. P., &Román, F. (2004). Amígdala, corteccia prefrontale e specializzazione emisferica nell’esperienza e espressione emotiva. Anales de Psicología, 20(2).
- Schienle, A., Schäfer, A., Walter, B., Stark, R., &Vaitl, D. (2005). Brain activation of spider phobics towards disorder-relevant, generally disgust-and fear-inducing pictures. Neuroscience Letters, 388(1), 1-6.


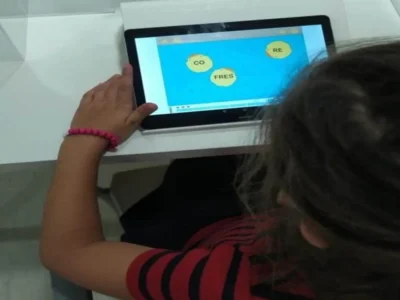



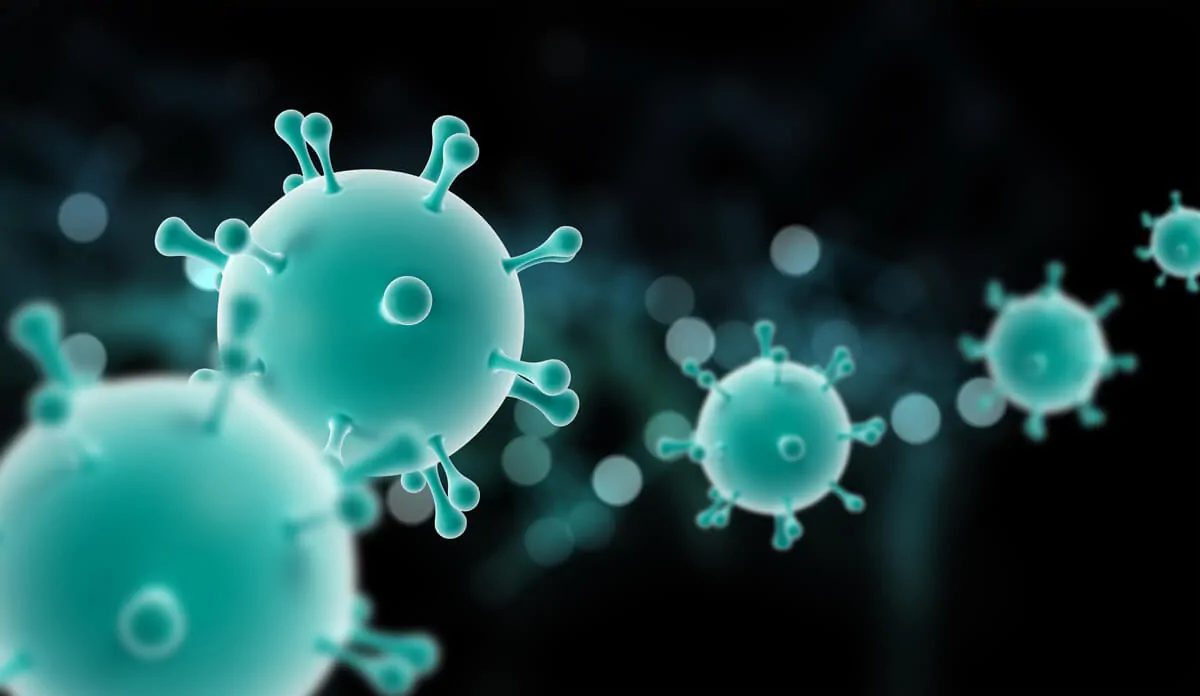


Lascia un commento