Il neuropsicologo Eriz Badiola spiega in questo articolo cos’è l’anosognosia, a cosa può essere associata e quali implicazioni ha nella vita quotidiana.
L’anosognosia è spesso un aspetto che rimane in secondo piano quando si parla di neuropsicologia. Pertanto, attraverso il presente articolo si intende spiegare cos’è, a cosa può essere associata e quali implicazioni ha nella vita quotidiana e in ambito clinico.
Cos’è l’anosognosia?
L’anosognosia, neologismo derivato dalle parole greche a (senza), nosos (malattia) e gnosis (conoscenza), letteralmente sarebbe qualcosa come “mancanza di conoscenza della malattia”. Cioè, la prospettiva su determinate limitazioni (cognitive, comportamentali, emotive o funzionali) della persona colpita differisce da quella di altre persone o dai risultati dei test oggettivi.
Ciò può verificarsi come conseguenza di lesioni cerebrali dovute a danno cerebrale acquisito o malattie neurodegenerative (Mograbi e Morris, 2018).
Questa difficoltà nel percepire le limitazioni può abbracciare vari aspetti: dal credere di poter vedere quando si soffre di cecità corticale a causa di danni al lobo occipitale (sindrome di Antón-Babinski), fino al non accorgersi di dimenticare la lista della spesa, passando per mettere in atto comportamenti prima non presenti e, ancora una volta, non esserne consapevoli.
Allo stesso modo, va indicato che l’anosognosia può essere parziale, essendo possibile che il paziente sia consapevole di qualche alterazione specifica, ma ne trascuri altre o addirittura minimizzi la rilevanza del problema.
Prova NeuronUP gratis per 7 giorni
Potrai collaborare con le nostre attività, progettare sedute o fare riabilitazione a distanza.
Storia dell’anosognosia
La scoperta di questa peculiare condizione risale al 1914, quando il neurologo franco-polacco Joseph Babinski (che potreste conoscere anche per il segno di Babinski, il riflesso plantare) stava lavorando con pazienti che avevano subito un ictus nell’emisfero destro e di conseguenza soffrivano di emiplegia sinistra. Nella traduzione in inglese del testo originale di Langer e Levine (2014) si descrive che quando a una delle pazienti veniva chiesto di sollevare entrambe le braccia, lei sollevava senza problemi il braccio destro e, quando toccava sollevare il sinistro, o non rispondeva o affermava di averlo sollevato. Evidentemente, non poteva sollevarlo, ma credeva di averlo fatto.
Anosodiaforia
Nell’articolo del 1914, il nostro amato Joseph coniò il neologismo anosognosia e aggiunse inoltre un altro termine in questo contesto: anosodiaforia (indifferenza). Questa parola la utilizzò per riferirsi alla condizione di quei pazienti in cui l’emiplegia era presente, ma l’importanza della paralisi passava in secondo piano. In altre parole: pur essendo consapevoli della loro emiplegia, non gliene importava affatto, non riferivano alcun disagio al riguardo (Langer e Levine, 2014).
Rimanevano molti aspetti in sospeso e da qui nacque un dibattito che si protrasse per gran parte del secolo scorso: l’anosognosia esiste veramente o il paziente finge? La nega?
Il dibattito tra anosognosia e negazione del deficit
Il nostro protagonista credeva nell’esistenza dell’anosognosia, sebbene non sapesse come dimostrarla, dato che per lui non aveva molto senso che un paziente fingesse per mesi e mesi che il suo braccio funzionasse perfettamente.
D’altra parte, alcuni autori sostengono che la negazione del deficit sia spiegabile attraverso il paradigma psicodinamico, collegando la mancanza di consapevolezza a resistenze o meccanismi di difesa (Ramachandran, 1995; Sims, 2014). Tuttavia, le attuali prospettive neuroscientifiche mettono in evidenza che l’uso di meccanismi di difesa dovrebbe essere contestualizzato in pazienti la cui anosognosia non dipende da alterazioni neurocognitive (Mograbi e Morris, 2018).
Attualmente sappiamo che l’anosognosia è una realtà in gran parte neuropsicologica e che determinate lesioni cerebrali possono causare questa condizione. Inoltre, esistono correlati neuroanatomici che ci aiutano a comprenderla.
Basi neuroanatomiche dell’anosognosia e prevalenza
Babinski suggeriva che l’anosognosia potesse dipendere da lesioni nell’emisfero destro e che le alterazioni sensoriali potessero influire sulla sua presenza (infatti, i pazienti non reagivano a stimoli esterni in tali estremità).
Oggi sarebbe un errore stabilire che una specifica lesione in un punto preciso possa provocare inevitabilmente alterazioni neuropsicologiche specifiche. Tuttavia, possiamo dire che lesioni in determinate strutture possono favorire l’insorgenza di tali alterazioni o che lesioni in diverse regioni siano potenzialmente associate alle stesse.
Come accennato in precedenza, la eziologia dell’anosognosia è varia, con un’incidenza compresa tra il 10 e il 18% nei pazienti che hanno subito ictus e presentano emiparesi, mentre si stima che fino all’81% delle persone diagnosticate con Alzheimer soffra di qualche forma di anosognosia e il 60% di coloro con deterioramento cognitivo lieve la sperimenti anch’esso (Acharya e Sánchez-Manso, 2018).
Nel caso dell’anosognosia per emiplegia, sebbene sia più comune in lesioni unilaterali destre o bilaterali, la frequenza di comparsa dell’anosognosia è simile nelle persone con lesioni (subcorticali e/o corticali) temporali, parietali o frontali. Tuttavia, la probabilità di anosognosia è maggiore in individui che presentano lesioni sia a livello frontale sia parietale, rispetto a lesioni in altre regioni cerebrali (Pia, Neppi-Modona, Ricci e Berti, 2004).

Iscriviti
alla nostra
Newsletter
Anosognosia nel deterioramento cognitivo lieve
In una revisione sistematica recente (Mondragón, Maurits e De Deyn, 2019) si osserva che nei pazienti con deterioramento cognitivo lieve è comune l’associazione tra l’anosognosia e la riduzione della perfusione, oltre che dell’attività nel lobo frontale e in strutture della linea mediana.
Anosognosia nella malattia di Alzheimer
Analogamente, per quanto riguarda l’anosognosia nella malattia di Alzheimer, negli studi esaminati si osserva una diminuzione della perfusione, dell’attivazione e del metabolismo nelle aree della linea mediana corticale, riscontrando lo stesso fenomeno in strutture parietotemporali negli stadi più avanzati della malattia.
Implicazioni nella valutazione e nella riabilitazione neuropsicologica
Innanzitutto, nella valutazione neuropsicologica è possibile che, a causa dell’anosognosia, il paziente ponga in dubbio la procedura. “Perché mi fai così tante domande?” mi diceva una paziente che era venuta per essere valutata prima di iniziare la riabilitazione neuropsicologica dopo un ictus. La mancata collaborazione durante la valutazione potrebbe ostacolarla e confrontare non sarebbe sempre una soluzione (nonostante possa sembrare ovvio, più avanti spiegherò il perché). Per questo motivo, e dato che la manifestazione dell’anosognosia è molto varia, durante la valutazione neuropsicologica si dovrebbero adattare i test alla situazione individuale e unica del paziente. Pertanto, spetterebbe al professionista decidere come affrontare la situazione con le competenze che acquisirà con l’esperienza.
Un’altra situazione che può verificarsi durante le sessioni di riabilitazione è che il paziente con problemi di memoria (ad esempio, persone con Alzheimer) ignori l’esistenza di deficit mnestici, con una probabilità di anosognosia tanto maggiore quanto più avanzata è la malattia (Hanseeuw et al., 2019). Ciò che accade con l’anosognosia associata ai problemi di memoria e alle persone che ne soffrono (soprattutto di memoria episodica) è che per quanto si confronti il paziente sull’esistenza di tali difficoltà, non risulta produttivo, poiché si sentiranno peggio e probabilmente alla seduta successiva non si ricorderanno di quanto accaduto. In tal senso, consiglio la visione di “Quando e come affrontare l’anosognosia?”, un video in cui si differenzia l’approccio per le persone con Alzheimer e per coloro che soffrono di DCA (Ruiz-Sánchez de León, 2020).
Per tutto ciò, non dobbiamo dimenticare di informare ed educare i familiari e i caregiver, affinché considerino l’anosognosia, poiché può essere fonte di conflitti in cui possano sentirsi male sia il paziente che il familiare. In questo contesto, due pilastri importanti per affrontare la situazione sono: comprensione ed empatia, sia da parte dei familiari che del neuropsicologo clinico.
In sintesi, l’anosognosia è una fedele compagna del danno cerebrale acquisito e delle malattie neurodegenerative, che dobbiamo considerare sia nella valutazione sia nella riabilitazione neuropsicologica. L’approccio deve essere adattato al paziente e affrontato da una prospettiva multidisciplinare. Allo stesso modo, è importante coinvolgere i familiari e renderli partecipi nel percorso verso il miglioramento della qualità della vita delle persone che vogliamo aiutare.
Bibliografia
- Acharya, A. B., e Sánchez-Manso, J. C. (2018). Anosognosia. StatPearls Publishing: Treasure Island (Florida).
- Hanseeuw, B. J., Scott, M. R., Sikkes, S. A., Properzi, M., Gatchel, J. R., Salmon, E., … e Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. (2020). Evolution of anosognosia in alzheimer’s disease and its relationship to amyloid. Annals of neurology, 87(2), 267-280.
- Langer, K. G., e Levine, D. N. (2014). Babinski, J. (1914). Contribution to the study of the mental disorders in hemiplegia of organic cerebral origin (anosognosia). Traducido por K.G. Langer & D.N. Levine. Traducido del original Contribution à l’Étude des Troubles Mentaux dans l’Hémiplégie Organique Cérébrale (Anosognosie). Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 61, 5–8.
- Mondragón, J. D., Maurits, N. M., e De Deyn, P. P. (2019). Functional neural correlates of anosognosia in mild cognitive impairment and alzheimer’s disease: a systematic review. Neuropsychology review, 29(2), 139-165.
- Mograbi, D. C., e Morris, R. G. (2018). Anosognosia. Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 103, 385-386.
- Pia, L., Neppi-Modona, M., Ricci, R., & Berti, A. (2004). The anatomy of anosognosia for hemiplegia: a meta-analysis. Cortex, 40(2), 367-377.
- Ruiz-Sánchez de León, J.M. [LOGICORTEX Neuropsicología]. (2020, 2 settembre). Quando e come affrontare l’anosognosia? [Archivio video]. Recuperato da https://www.youtube.com/watch?v=uJi7_v_CluM
- Ramachandran, V. S. (1995). Anosognosia in parietal lobe syndrome. Consciousness and cognition, 4(1), 22-51.
- Sims, A. (2014). Anosognosia and the very idea of psychodynamic neuroscience (No. Ph. D.). Deakin University.
Altra bibliografia consigliata
- Orfei, M. D., Caltagirone, C., e Spalletta, G. (2009). The evaluation of anosognosia in stroke patients. Cerebrovascular diseases, 27(3), 280-289.
- Starkstein, S. E. (2014). Anosognosia in Alzheimer’s disease: diagnosis, frequency, mechanism and clinical correlates. Cortex, 61, 64-73.

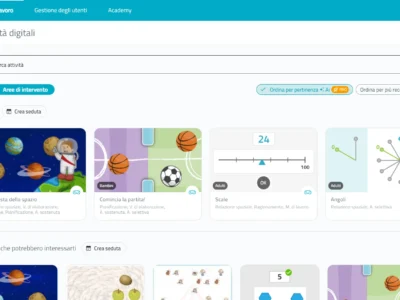


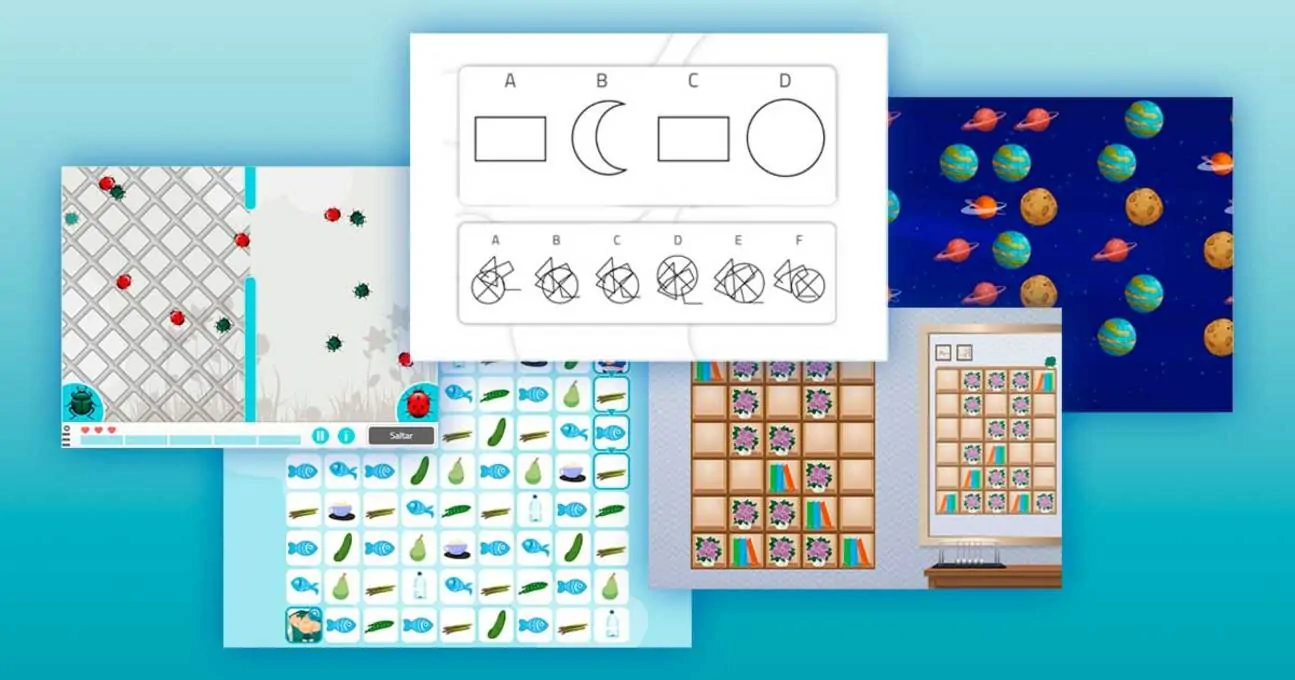
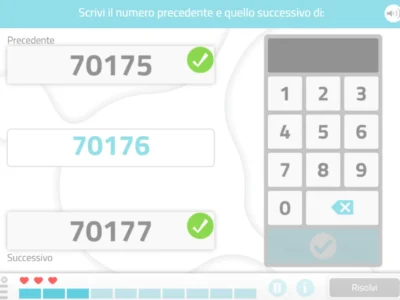



Lascia un commento