La dottoressa in Psicologia Clinica della Salute María J. García-Rubio insieme alla specialista in neuropsicologia clinica e nel disturbo cognitivo maggiore Nancy Navarro spiegano in questo articolo cos’è la esplorazione neurologica, nonché le sue tecniche e applicabilità clinica.
Introduzione
La conoscenza della struttura e della funzione del sistema nervoso (SN) richiede la congiunzione di discipline quali la fisiologia, la medicina, la psicologia e la biologia, tra le altre. Per questo molte di esse formano le neuroscienze e le tappe fondamentali che ne accompagnano lo sviluppo come ramo specifico dello studio del SN nelle sue versioni sana e patologica.
Per condurre gli studi scientifici che raccolgono informazioni sullo sviluppo del SN, le sue parti e il suo funzionamento è necessaria una metodologia comune a queste discipline che si uniscono intorno all’esplorazione neurologica. Ed è da qui che nascono le tecniche di esplorazione neurologica.
Che cos’è l’esplorazione neurologica?
L’esplorazione neurologica è l’azione tramite la quale si possono trarre conclusioni precise sulla struttura e funzione di diversi aspetti del sistema nervoso (González e López, 2013), essendo un fattore chiave il tipo di tecnica di esplorazione neurologica e il meccanismo che la sottende.
Tecniche di esplorazione neurologica
Lo sviluppo delle tecniche di esplorazione neurologica risale all’evoluzione del concetto di cervello, che coincide con il periodo di alcune delle ben note teorie filosofiche come quella di Ippocrate (c. 460-370 a.C.), che descrisse il cervello come la sede dell’esperienza e dell’intelligenza.
Andrea Vesalio (1514-1564) fu il primo a descrivere l’anatomia del cervello attraverso illustrazioni raccolte nella sua opera “De humani corporis”; e anche René Descartes (1596-1650) descrive il cervello come una macchina complessa, simile al cuore, che controlla le azioni complesse dell’essere umano.

La pneumoencefalografia
Nel 1919, Walter Dandy (1886-1946) sviluppò la pneumoencefalografia, un metodo che consisteva nel realizzare una radiografia del cervello mediante la sostituzione del liquido cerebrale con aria, ossigeno o elio.
L’elettroencefalogramma
Dopo questa prima tecnica di esplorazione neurologica, arrivò l’elettroencefalogramma grazie al tedesco Hans Berger (1873-1941) come un metodo capace di rivoluzionare l’esplorazione neurologica conosciuta fino ad allora. Infatti, con l’EEG il ricercatore non ottiene una radiografia del cervello, ma può conoscere i tempi e le aree cerebrali in cui si verifica l’attività cerebrale basata su potenziali postsinaptici registrati sul cuoio capelluto della persona.
Altre tecniche di esplorazione neurologica e loro varianti
Successivamente, altre tecniche di esplorazione neurologica furono la angiografia derivata dalla lobotomia del XX secolo. Tuttavia, fu alla fine degli anni ’60 che emersero le tecniche di esplorazione neurologica funzionali come la magnetoencefalografia (MEG) di Cohen (1968), la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica (RM), insieme allo sviluppo della tomografia a emissione di positroni (PET) (Posner e Raichle, 1994).
Infine, negli anni ’80 e successivi sono state create nuove varianti di queste stesse tecniche di esplorazione neurologica con le quali i ricercatori sono in grado di estrarre dati cerebrali sempre più precisi e interessanti.
Sono esempi la tecnica di stimolazione magnetica transcranica (TMS), la tomografia da risonanza magnetica funzionale (fMRI) e le sue diverse applicazioni, tra cui spiccano i segnali BOLD, la T1 e la T2. Inoltre, dal 1994 si accede all’esplorazione neurologica a partire da dati di imaging provenienti da tecniche più recenti come il tensore di diffusione, che permette di visualizzare il percorso delle fibre nervose, tra gli altri (Fuller, 2020).
Metodi di esplorazione neurologica
In questo articolo forniremo un breve riepilogo dei metodi di esplorazione neurologica esistenti e ci concentreremo soprattutto sui metodi funzionali che sono i più utilizzati attualmente grazie al loro grande contributo negli studi di neuroscienze cognitive sugli esseri umani.
Metodi lesionali
I metodi lesionali sono tecniche di esplorazione neurologica che utilizzano lesioni cerebrali come ipotesi per comprendere il funzionamento del cervello in relazione a un comportamento, ovvero analizzano strutture cerebrali danneggiate e la loro influenza sul comportamento.
La loro metodologia è ampia per lo studio di diversi scenari, sia per lesioni che si sono verificate spontaneamente a causa di un danno cerebrale acquisito, sia per lesioni derivanti da un procedimento chirurgico (Humphreys et al., 2021).
Tra questi metodi spiccano l’analisi macroscopica e microscopica, il cui scopo è fornire informazioni sulla composizione morfologica e architettonica del tessuto nervoso post-mortem. Quanto sopra avviene mediante procedure come fissazione, colorazione o sezione, per conoscere la natura chimica e molecolare a livello macroscopico o microscopico.
Metodi strumentali
Questi metodi consentono l’esplorazione neurologica attraverso il registro e l’osservazione delle prestazioni cerebrali in diverse attività, mediante strumenti adeguati specificamente per controllare le variabili che influenzano indirettamente il funzionamento del cervello (Marinescu et al., 2018).
Alcune tecniche di esplorazione neurologica in questa categoria sono le tecniche sensoriali, derivanti dal paradigma della divisione sensoriale, secondo il quale diverse informazioni in ingresso vengono manipolate in modo tale che vari stimoli controllati raggiungano simultaneamente entrambi gli emisferi cerebrali e competono per l’arrivo. Tra queste spiccano la udito dicotico, campi visivi separati e palpazione diadittica (Maes et al., 2017; Vendetti et al., 2015).
Anche le tecniche motorie come l’interferenza motoria sono metodi strumentali di esplorazione neurologica, che richiedono che il partecipante esegua contemporaneamente due compiti motori, per esempio con il test del battito.
Metodi funzionali
I metodi funzionali sono quelli che registrano cambiamenti nelle attività cerebrali, mediante la manipolazione di variabili comportamentali. All’interno di questa categoria, si distinguono le tecniche di esplorazione neurologica elettromagnetiche e metaboliche.
Tecniche elettromagnetiche: tra queste si distinguono l’elettroencefalografia, i potenziali evocati e la magnetoencefalografia.
— Elettroencefalogramma
È una tecnica non invasiva che permette di studiare il sistema nervoso centrale. Attraverso di essa si accede all’esplorazione cerebrale mentre si svolgono diverse attività in risposta a stimoli differenti.
Il metodo permette di amplificare l’attività bioelettrica cerebrale, rilevando l’attività dei campi elettrici generati dai potenziali postsinaptici dei neuroni piramidali della corteccia. I pattern di onde gamma, beta, theta e delta generati dal processo sono associati al comportamento e alla coscienza, essendo misurati in base alla loro frequenza e ampiezza.
Le principali condizioni cliniche che possono essere rilevate con questa tecnica sono: la diagnosi dei disturbi epilettici, la classificazione delle patologie del sonno, le alterazioni a livello di coscienza (Keren et al., 2018).
— Potenziali evocati (PE)
Misurano i cambiamenti nell’attività elettrica cerebrale mediante uno stimolo sensoriale esterno. L’attività è rilevata da elettrodi posizionati sul cuoio capelluto, che forniscono informazioni come indicatore dell’attività neurale (Bestmann e Krakauer, 2015).
Questi potenziali sono utilizzati per la valutazione della via uditiva e studi su: neonati a rischio di ipoacusia, malattie degenerative e demielinizzanti (Norcia et al., 2015).
— Magnetoencefalografia
Consiste in un esame che misura i campi magnetici generati dalle correnti elettriche cerebrali e rileva i cambiamenti in aree specifiche. Il procedimento prevede una o più sonde che si muovono sulla superficie del cranio e producono una mappa di isocontorni che rappresentano diverse intensità del campo magnetico.
Nella pratica clinica questa tecnica di esplorazione neurologica è utilizzata per localizzare il focolaio delle crisi epilettiche (Förster et al., 2020).
Tecniche metaboliche: quegli strumenti di esplorazione neurologica che permettono di rilevare il livello di attività metabolica cerebrale. A questo scopo vengono utilizzate le seguenti tecniche: tomografia a emissione di positroni, tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli e risonanza magnetica funzionale.
— Tomografia a emissione di positroni (PET)
Viene impiegata per esplorare l’attività metabolica neuronale mediante radiomarcatori che permettono di misurare il flusso sanguigno, i meccanismi di trasporto della dopamina o il riassorbimento della serotonina.
Questo processo non comporta rischi per il paziente; al contrario, le molecole radioattive emettono particelle chiamate positroni per determinare la regione cerebrale da esplorare e creare un’immagine colorata dell’encefalo (O’Neill et al., 2015). Questo metodo è ampiamente utilizzato nella rilevazione delle malattie neurodegenerative.
— Tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli (SPECT)
È una tecnica utilizzata nel campo della medicina nucleare. Combina immagini bidimensionali che, combinate, formano un’unica immagine tridimensionale.
Questa tecnica di esplorazione neurologica è ampiamente utilizzata nella valutazione della malattia cerebrovascolare e in pazienti con sospetto di sindrome demenza e/o lesione cerebrale traumatica (Pelegrí Martínez et al., 2017).
— Risonanza magnetica funzionale (fMRI)
Permette di misurare il metabolismo regionale rilevando l’ossigeno nei vasi sanguigni dell’encefalo. La spiegazione fisiologica mostra che, man mano che i neuroni sono più attivi, utilizzano una maggiore quantità di ossigeno, il che provoca una riduzione di questo nel sangue (Keren et al., 2018).
I neuroni inviano segnali ai vasi sanguigni per generare vasodilatazione e trasportare ossigeno. La fMRI rende compatibile questo percorso con un’elevata precisione nella localizzazione delle strutture encefaliche.
L’impiego di queste tecniche di esplorazione neurologica è vario; attualmente è utilizzato nel campo delle Neuroscienze Cognitive e Affective con popolazione sana o con diagnosi neuropatologica (Atenas et al., 2018).
Conclusioni
In questo articolo del blog è stato introdotto lo sviluppo e lo stato delle tecniche di esplorazione neurologica, con particolare attenzione alle tecniche funzionali da cui si ottengono dati di imaging, specialmente riferiti alla funzione cognitiva dell’essere umano a riposo e/o mentre svolge un compito a elevata o bassa richiesta, per esempio.
Allo stesso modo, queste tecniche permettono l’esplorazione neurologica del cervello sano e anche di quello patologico.
In conclusione, le tecniche di esplorazione neurologica costituiscono uno dei metodi più attuali, innovativi e in evoluzione nelle neuroscienze a livello nazionale e internazionale, per l’applicabilità che offrono come procedimento e per la qualità e adeguatezza dei loro risultati.
Bibliografia
Atenas, T. L., Díaz, E. C., Quiroga, J. C., Arancibia, S. U., & Rodríguez, C. C. (2018). Functional magnetic resonance imaging: Basic principles and application in the neurosciences. Radiología, 60(5), 368-377. https://doi.org/10.1016/j.rxeng.2018.04.001
Bestmann, S., & Krakauer, J. W. (2015). The uses and interpretations of the motor-evoked potential for understanding behaviour. Experimental brain research, 233, 679-689. https://doi.org/10.1007/s00221-014-4183-7
Förster, J., Koivisto, M., & Revonsuo, A. (2020). ERP and MEG correlates of visual consciousness: The second decade. Consciousness and cognition, 80, 102917. https://doi.org/10.1016/j.concog.2020.102917
Fuller, G. (2020). Exploración neurológica fácil. Elsevier Health Sciences.
González, N. C., & López, J. A. T. (2013). Manual para la exploración neurológica y las funciones cerebrales superiores. Manual Moderno.
Humphreys, C. A., Smith, C., & Wardlaw, J. M. (2021). Correlations in post‐mortem imaging‐histopathology studies of sporadic human cerebral small vessel disease: a systematic review. Neuropathology and applied neurobiology, 47(7), 910-930. https://doi.org/10.1111/nan.12737
Keren, H., O’Callaghan, G., Vidal-Ribas, P., Buzzell, G. A., Brotman, M. A., Leibenluft, E., … & Stringaris, A. (2018). Reward processing in depression: a conceptual and meta-analytic review across fMRI and EEG studies. American Journal of Psychiatry, 175(11), 1111-1120. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17101124
Maes, C., Gooijers, J., de Xivry, J. J. O., Swinnen, S. P., & Boisgontier, M. P. (2017). Two hands, one brain, and aging. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 75, 234-256. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.01.052
Marinescu, I. E., Lawlor, P. N., & Kording, K. P. (2018). Quasi-experimental causality in neuroscience and behavioural research. Nature human behaviour, 2(12), 891-898. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0466-5
Norcia, A. M., Appelbaum, L. G., Ales, J. M., Cottereau, B. R., & Rossion, B. (2015). The steady-state visual evoked potential in vision research: A review. Journal of vision, 15(6), 4-4. https://doi.org/10.1167/15.6.4
O’Neill, G. C., Barratt, E. L., Hunt, B. A., Tewarie, P. K., & Brookes, M. J. (2015). Measuring electrophysiological connectivity by power envelope correlation: a technical review on MEG methods. Physics in Medicine & Biology, 60(21), R271. 10.1088/0031-9155/60/21/R271
Pelegrí Martínez, L., Kohan, A. A., & Vercher Conejero, J. L. (2017). Optimización de los protocolos y del uso de contrastes en tomografía computarizada de los equipos de tomografía por emisión de positrones. Radiología, 64-74.
Posner, M.I., & Raichle, M.E. (1994). Images of Mind. Scientific American Library.







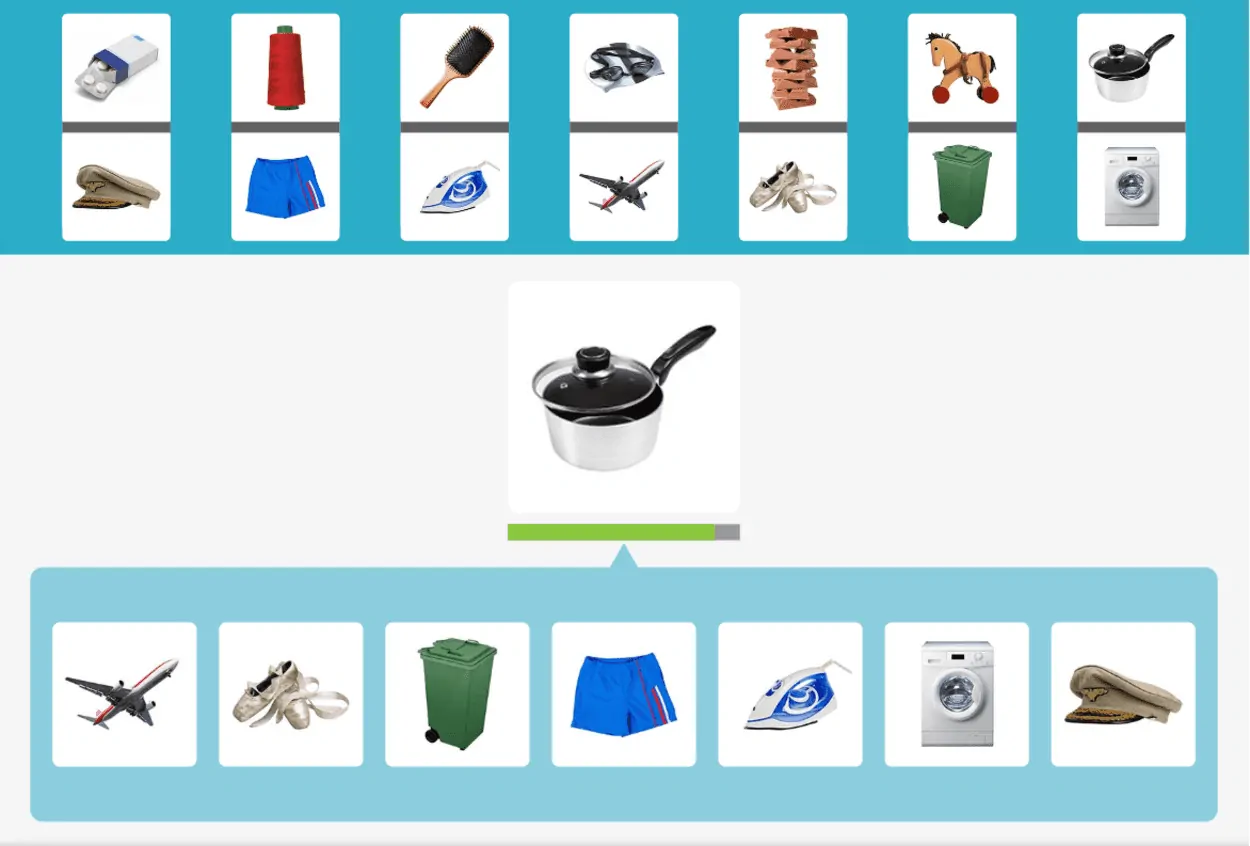

Lascia un commento