Il neuropsicologo Aarón F. del Olmo spiega il disturbo dell’apprendimento non verbale (DANV), le sue principali caratteristiche e il suo problema diagnostico.
Pur partendo dall’idea che, quando eseguiamo un compito, tutto il cervello vi partecipi, risulta allettante tentare di segmentare la cognizione per studiarla. Forse più che allettante, ci dà una falsa sensazione di sicurezza, come accade quando affrontiamo le funzioni esecutive (García-Molina, 2018; Tirapu-Ustárroz, Molina, Lago, & Ardila, 2012). Ma, come è noto, in quell’esecuzione agiscono congiuntamente molte di queste funzioni in modo piuttosto ben sincronizzato. E quella sincronizzazione, e il modo in cui automatizziamo il nostro funzionamento, si ottiene durante lo neurosviluppo.
In questo neurosviluppo esistono disturbi o difficoltà abbastanza conosciuti da chi lavora nell’ambito della neuropsicologia infantile, dove spicca senza dubbio il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), disturbo che ancora genera un acceso dibattito sulla sua esistenza e/o prevalenza reale. Ma in generale, e con il permesso del disturbo dello spettro autistico (ASD) (uno degli altri disturbi più noti), è abbastanza frequente trovare diagnosi che indicano problemi nello sviluppo dell’emisfero sinistro, come possono essere il disturbo specifico del linguaggio (DSL), la dislessia o la disgrafia.
Tuttavia, quando si passa all’altro emisfero, il destro, risulta più complicato trovare informazioni su disturbi legati a un funzionamento non corretto di quest’ultimo.
Tuttavia, Johnson e Myklebust (1967) avevano già descritto quasi 50 anni fa un profilo cognitivo nei bambini che, lontano dall’avere difficoltà negli apprendimenti tipici o legati al linguaggio, presentavano altri tipi di problemi, che alla fine risultano più difficili da oggettivare, in quello che hanno definito disturbo dell’apprendimento non verbale (DANV).
L’obiettivo del presente post è descriverlo, data la grande ignoranza che abbiamo su di esso, e riflettere sul motivo di ciò. Un motivo che sembra essere proprio alla base del problema diagnostico a livello generale nei disturbi del neurosviluppo e della ragione per cui non sia riconosciuto come tale nella guida diagnostica di uso comune, il DSM-V.
Come detto, Johnson e Myklebust (1967) individuarono un campione di bambini che presentavano problemi di tipo visuo-spaziale, di coordinazione motoria e di comprensione del contesto sociale, molto legati alla difficoltà nell’interpretare i gesti associati al linguaggio non verbale, che collegarono al funzionamento dell’emisfero destro.
È chiaro che queste difficoltà, che riguardano maggiormente gli aspetti manipolativi e percettivi, rappresentano un handicap in materie “meno rilevanti” nel curriculum scolastico (educazione fisica, musica o arte), il che ci parla di una asimmetria anche a livello accademico, dove le abilità dell’emisfero destro hanno meno peso di quelle sinistre (García-Nonell, Rigau-Ratera, & Pallarés, 2006).
Caratteristiche del disturbo dell’apprendimento non verbale
Harnadek e Rourke (1994) hanno descritto questo quadro con le seguenti caratteristiche:
- Deficit bilaterali nella percezione tattile, leggermente più marcati nell’emicorpo sinistro,
- deficit bilaterali nella coordinazione psicomotoria, anch’essi lievemente più marcati nell’emicorpo sinistro,
- difficoltà nell’organizzazione visuo-spaziale,
- difficoltà a lavorare con informazioni nuove e ad adattarsi a situazioni complesse e inedite,
- deficit nella risoluzione di compiti non verbali, nella formazione di concetti e nell’elaborazione di ipotesi,
- difficoltà nella percezione del senso del tempo,
- buono sviluppo delle abilità verbali automatizzate,
- logorrea caratterizzata da un linguaggio meccanico e ripetitivo, nell’ambito dei disturbi della pragmatica del linguaggio,
- deficit nella meccanica aritmetica,
- importanti deficit nella percezione, nel giudizio e nell’interazione sociale.
In un certo senso, si può dire che questi bambini presentino una capacità verbale spesso superiore a quella che ci si aspetta per la loro età, segno che l’emisfero sinistro agisce compensando in parte le difficoltà a livello di emisfero destro. Proprio il contrario di quanto accade nei bambini con alterazioni del linguaggio che compensano la comprensione dell’ambiente in modo visivo.
Aree fondamentali all’interno del DANV
Ora ci concentreremo su tre ambiti considerati più “nucleari” in questo disturbo:
Coordinazione motoria
Una delle alterazioni più facilmente osservabili riguarda l’acquisizione delle routine motorie. In questo senso, vi sarebbe un ampio sovrapposizione con la diagnosi di disturbo dello sviluppo della coordinazione motoria presente nel manuale DSM-IV.
Partendo da questa idea, i bambini con disturbo dell’apprendimento non verbale potrebbero presentare difficoltà nella coordinazione motoria, dispraxia e in generale verrebbero considerati nel loro ambiente bambini “goffi”, evitando giochi che richiedono abilità motorie.
Questo profilo risulta così rilevante che altri autori (Crespo-Eguílaz & García, 2009) lo considerano un asse centrale in una delle ridefinizioni del DANV che propongono, il disturbo procedurale dell’apprendimento (DPA).
In questo senso, cercando un’analogia, mentre nel DSL l’automatizzazione del linguaggio è compromessa, o in altre etichette, quella dell’apprendimento della lettura o della scrittura, nel DANV il raggiungimento dei “traguardi” motori sarebbe sensibilmente più lento e, inoltre, l’apprendimento dei pattern motori richiederebbe molto più tempo e fatica per i soggetti interessati.
Tra i test abitualmente usati per osservare questa coordinazione motoria troviamo la batteria specifica MACB-2 o diverse subprove della NEPSY-II o Cumanin, anche se non è una cattiva idea ricordare che bisogna osservare più aspetti e non solo il punteggio ottenuto in questi test.
Percezione visuo-spaziale
D’altra parte, a livello visuo-spaziale, i bambini con DANV possono avere difficoltà nell’integrazione percettiva, in particolare nel dare forma visiva a stimoli incompleti, nonché difficoltà nel percepire correttamente l’orientamento di elementi, proporzioni e distanze.
Queste alterazioni sono difficili da cogliere a prima vista, principalmente per la soggettività dell’esperienza percettiva, ma possono causare una difficoltà significativa nell’interpretazione del materiale visivo, che secondariamente influisce sulla memorizzazione di questo tipo di materiale.
D’altra parte, quando si parla dell’emisfero destro, che è prevalentemente visivo, esso gioca un ruolo importante anche nell’interpretazione globale dell’ambiente. Questo, evidentemente, ha un impatto non solo sulla comprensione degli aspetti visivi ma anche sull’integrazione della comunicazione non verbale, come vedremo nel punto successivo.
Linguaggio non verbale
Uno dei grandi problemi associati al DANV è la difficoltà nell’interpretazione del linguaggio non verbale, che ha un peso considerevole nella comunicazione, spesso invertendo il significato di quanto espresso verbalmente. Aspetti come la prosodia e i significati non letterali sfuggono ai bambini con queste difficoltà, e inoltre risulta difficile interpretare ed esprimere questo linguaggio non verbale, influenzando direttamente la loro interazione sociale con i pari.
Quest’ultimo aspetto è ciò che porta anche altri autori (Crespo-Eguílaz & García, 2009) a proporre l’etichetta DPA e a generare criteri più organizzati per definire questo disturbo. Considerare semplicemente come disturbo del linguaggio non verbale una sindrome che include anche aspetti prosodici suona un po’ incoerente.
Impatto emotivo
È importante sottolineare che tutte queste alterazioni hanno un notevole impatto emotivo sul bambino. Principalmente per le etichette di “goffo” o “strano” che emergono a causa dell’impatto delle loro difficoltà sulla sfera sociale.
La mancata individuazione o la scarsa conoscenza di questo disturbo porta a interpretare il comportamento del bambino come intenzionale (pigro o svogliato per il fatto di avere insufficienze in materie che risultano “facili”), rendendo il bambino molto consapevole dei propri limiti e scontrandosi continuamente con essi al non ricevere adeguati adattamenti. Questo aspetto contrasta notevolmente con altri disturbi dalla sintomatologia più evidente, poiché il bambino con DANV attribuisce internamente il proprio rendimento.
Una breve riflessione finale
All’ignoranza sul disturbo dell’apprendimento non verbale possiamo aggiungere l’ignoranza su come affrontare i disturbi del neurosviluppo. Del resto, sembra che il lavoro in questo ambito sia orientato a far rientrare il bambino in etichette preesistenti e a individuare comportamenti senza interrogarsi sulle cause.
In particolare, molti bambini con disturbo dell’apprendimento non verbale hanno difficoltà attentive, ma derivano dalla difficoltà a elaborare correttamente gli aspetti visivi o almeno a automatizzarne il processamento, senza arrivare ad avere un vero disturbo dell’attenzione. E questo ci riporta di nuovo al principio di questo post. Il comportamento osservabile è il risultato dell’interazione di numerosi processi sincronizzati durante il neurosviluppo. Inoltre, è difficile non avere la sensazione di restare in superficie rispetto al problema se non si considera come si è sviluppato il processo, la storia del bambino e, in definitiva, cosa causa quel modo di eseguire i compiti.
Forse è proprio per questo che è più difficile descrivere il DANV e vederlo inserito in guide diagnostiche che cercano di creare etichette il più “ermetiche” possibile. E anche, perché no, orientate a diagnosi rapide.
È quindi importante sottolineare che, pur esistendo una serie di segni all’interno di ciò che sarebbe il DANV, esiste un profilo diverso per ogni bambino, sia nei segni presenti, sia nel modo in cui si manifestano (che varia anche con l’età) e nell’impatto che hanno per ogni bambino e la sua famiglia nella vita quotidiana. E senz’altro questa analisi porta a comprendere meglio come fornire gli supporti necessari per un migliore adattamento al mondo che li circonda, che alla fine è l’obiettivo che perseguiamo: aiutare.
Bibliografia
- Crespo-Eguílaz, N., & García, J. N. (2009). Disturbo procedurale dell’apprendimento: caratteristiche neuropsicologiche. Revista de neurología, 49(8), 409-416.
- García-Molina, A. (2018). Valutazione delle funzioni esecutive.
- García-Nonell, C., Rigau-Ratera, E., & Pallarés, J. A. (2006). Profilo neurocognitivo del disturbo dell’apprendimento non verbale. Revista de neurología, 43(5), 268-274.
- Harnadek, M. C., & Rourke, B. P. (1994). Principal identifying features of the syndrome of nonverbal learning disabilities in children. Journal of Learning Disabilities, 27(3), 144-154. https://doi.org/10.1177/002221949402700303
- Johnson, D. J., & Myklebust, H. R. (1967). Learning Disabilities; Educational Principles and Practices.
- Tirapu-Ustárroz, J., Molina, A. G., Lago, M. R., & Ardila, A. A. (2012). Neuropsicología de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas. Recuperato da https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=557535





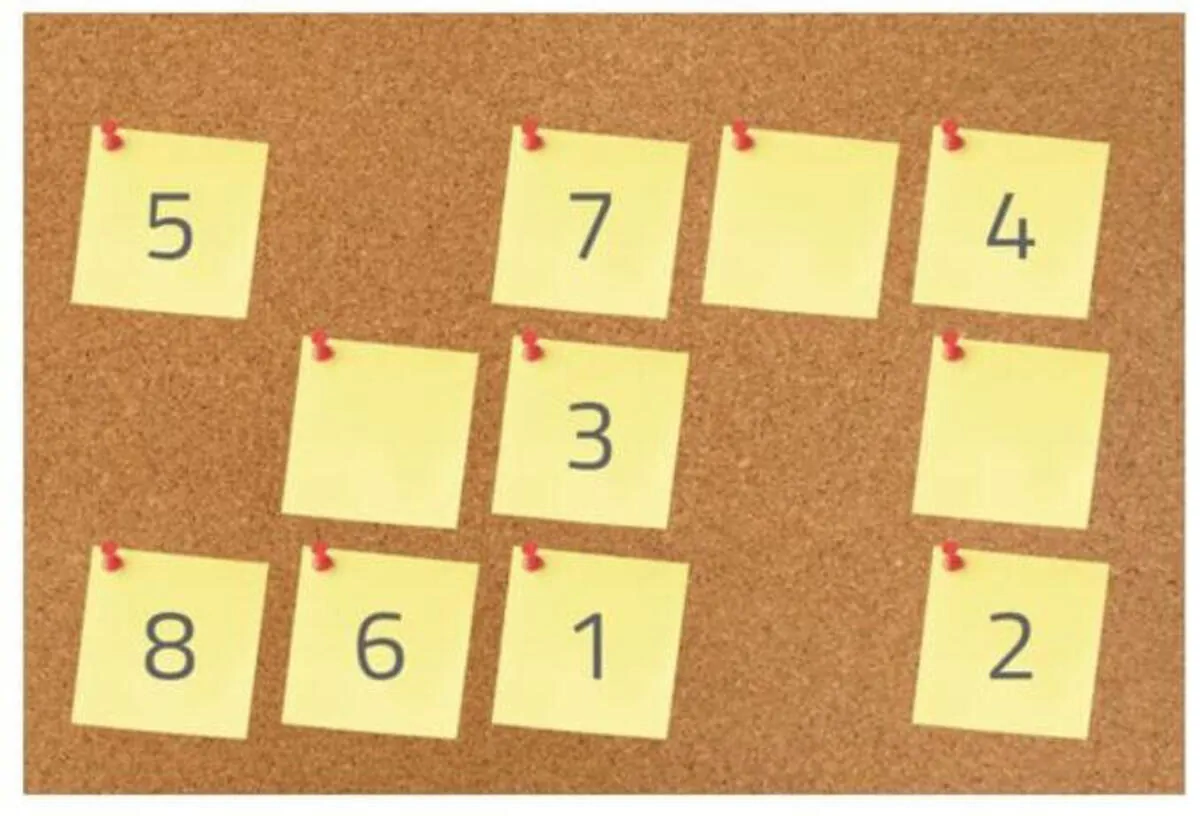



Lascia un commento