Lo sapevi che la memoria non è un sistema unico e indivisibile? Dall’Associazione Murciana di Neuroscienza ci spiegano il concetto non unitario di memoria.
La memoria
Una delle capacità cognitive di base su cui si fonda l’adattamento dell’essere umano alle esigenze ambientali è la memoria. Infatti, questo processo cognitivo è studiato in molti campi del sapere, non solo in quelli psicologici.
Da quando è stato abbandonato il concetto unitario di memoria – che definiva la memoria come un sistema unico e indivisibile –, sono sempre più numerosi gli studi, raccolti in diverse discipline e metodologie, che esplorano i diversi sistemi mnemonici. Questi sono stati raccolti e classificati, sia negli approcci classici che in quelli attuali, tenendo conto di due fattori principali: il corso temporale della memoria, da un lato, e il tipo di informazione immagazzinata, dall’altro.
Secondo il suo corso temporale, si ritiene che la formazione della memoria segua una progressione da una forma breve e instabile, che ha luogo immediatamente dopo l’apprendimento fino a una forma più stabile e duratura, che si manifesta dopo un periodo di tempo più o meno lungo dall’acquisizione dell’informazione.
Tra questi due estremi si forma un continuum che comprende diversi tipi di memoria: memoria sensoriale, memoria a breve termine, memoria di lavoro e memoria a lungo termine. Questi depositi di memoria sono inglobati all’interno dei modelli “multimagazzino o multisistema” della memoria e si differenziano tra loro per la capacità di informazione che consentono e per la durata durante la quale l’informazione permane al loro interno.
D’altra parte, questi tipi di memoria sono considerati processi continui che comprendono fasi specifiche.
Fasi specifiche
- Acquisizione: apprendimento.
- Consolidamento: memoria.
- Recupero.
- Riconsolidamento: È la più recente. Numerosi studi neurobiologici ne hanno confermato l’indipendenza.
La distinzione in base al materiale che comprende il sistema di memoria si è generalmente basata sullo studio di pazienti con lesioni cerebrali specifiche. In particolare, si è osservato che pazienti con lesioni specifiche presentavano alterazioni mnestiche specifiche.
Ad esempio, il paziente J.P. aveva difficoltà ad aumentare le prestazioni in compiti che dipendevano dalla ripetizione e dall’esposizione di abilità acquisite in precedenza, mentre altre abilità rimanevano intatte; inoltre, sempre nel caso di J.P., quest’ultimo era in grado di richiamare consapevolmente un evento passato.
Da questa specificità della memoria emerse un’altra classificazione basata sul contenuto dell’informazione che comportò la scissione della memoria a lungo termine in due tipologie: la memoria dichiarativa o esplicita e la memoria non dichiarativa o implicita.
Tipi di memoria a lungo termine
1. Memoria dichiarativa o esplicita
La memoria dichiarativa si occupa di codificare l’informazione sugli avvenimenti biografici e sulla conoscenza di eventi concreti. In questo senso, comporta uno sforzo da parte della persona per ricordare informazioni precedentemente accadute, denominato anche ricordo intenzionale.
Generalmente, il suo richiamo è spesso motivato da uno stimolo evocativo presente al momento della codifica dell’informazione, che facilita l’evocazione.
Sistemi della memoria dichiarativa
I tre sistemi compresi all’interno della memoria dichiarativa sono:
- La memoria semantica,
- la memoria episodica,
- la memoria di riconoscimento, un tipo speciale di memoria che sarà oggetto di questa tesi.
2. Memoria dichiarativa o implicita
D’altra parte, la memoria implicita comporta le abilità o competenze percettive, motorie e cognitive già acquisite e che possono essere recuperate solo attraverso l’azione, essendo impossibile da “dichiarare” verbalmente. In questo caso, il ricordo viene quantificato in modo diverso; in particolare, si afferma che c’è stato apprendimento implicito se si osserva un aumento delle prestazioni in determinati compiti.
Pertanto, questo tipo di memoria si osserva quando ci sono cambiamenti nel comportamento dovuti a un apprendimento precedente di cui la persona non è consapevole.
Esempi di memoria dichiarativa o implicita
Alcuni esempi di memoria implicita sono:
- Il condizionamento classico,
- i meccanismi di priming,
- la memoria procedurale.
Conclusione
Globalmente, si conclude che la memoria non è un sistema unitario indivisibile, ma si compone di diversi sistemi funzionali che differiscono nel loro corso temporale, nel contenuto dell’informazione immagazzinata e, inoltre, nelle basi neurali che li sostengono.
Bibliografia
- Carretié, L. (2016). Anatomía de la mente (2a ed.). Madrid, Spagna: Pirámide.
- Phelps, E. A. (2004). Human emotion and memory: interactions of the amygdala and hippocampal complex. Current opinion in neurobiology, 14(2), 198-202.
- Rugg, M. D., Mark, R. E., Walla, P., Schloerscheidt, A. M., Birch, C. S. e Allan, K. (1998). Dissociation of the neural correlates of implicit and explicit memory. Nature, 392(6676), 595-598.
- Squire, L. R. (1992). Memory and the hippocampus: a synthesis from findings with rats, monkeys, and humans. Psychological review, 99(2), 195.
- Tobias, B. A., Kihlstrom, J. F. e Schacter, D. L. (1992). Emotion and implicit memory. The handbook of emotion and memory: Research and theory, 1, 67-92.




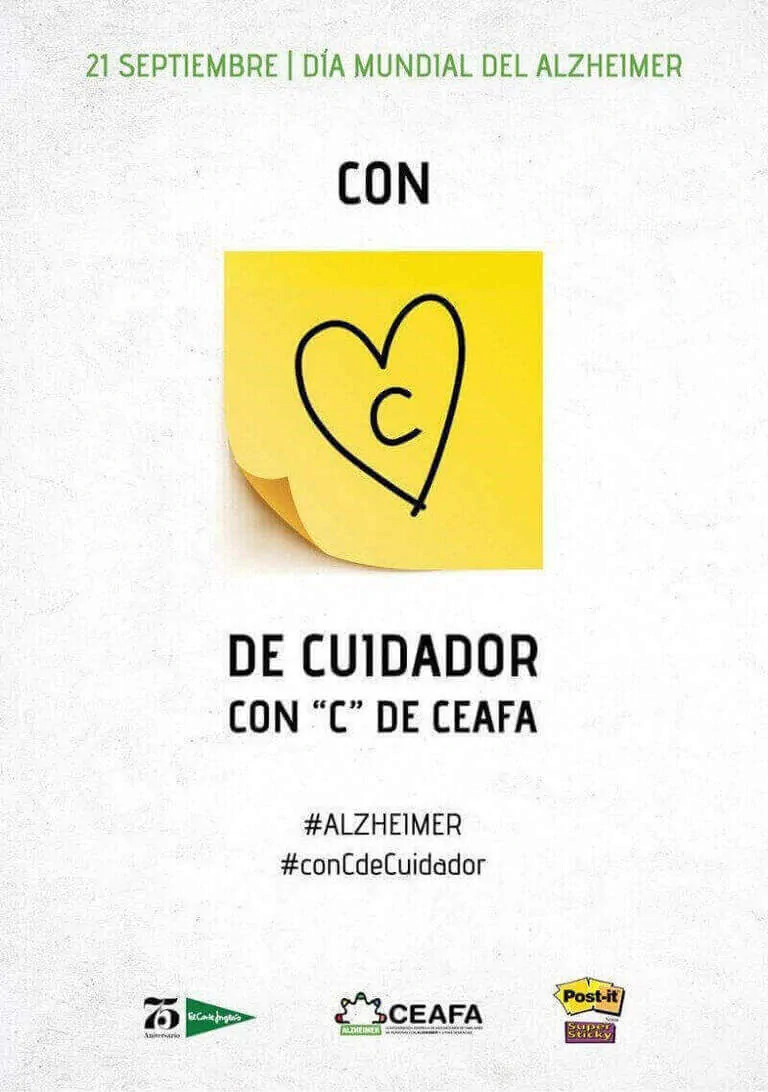

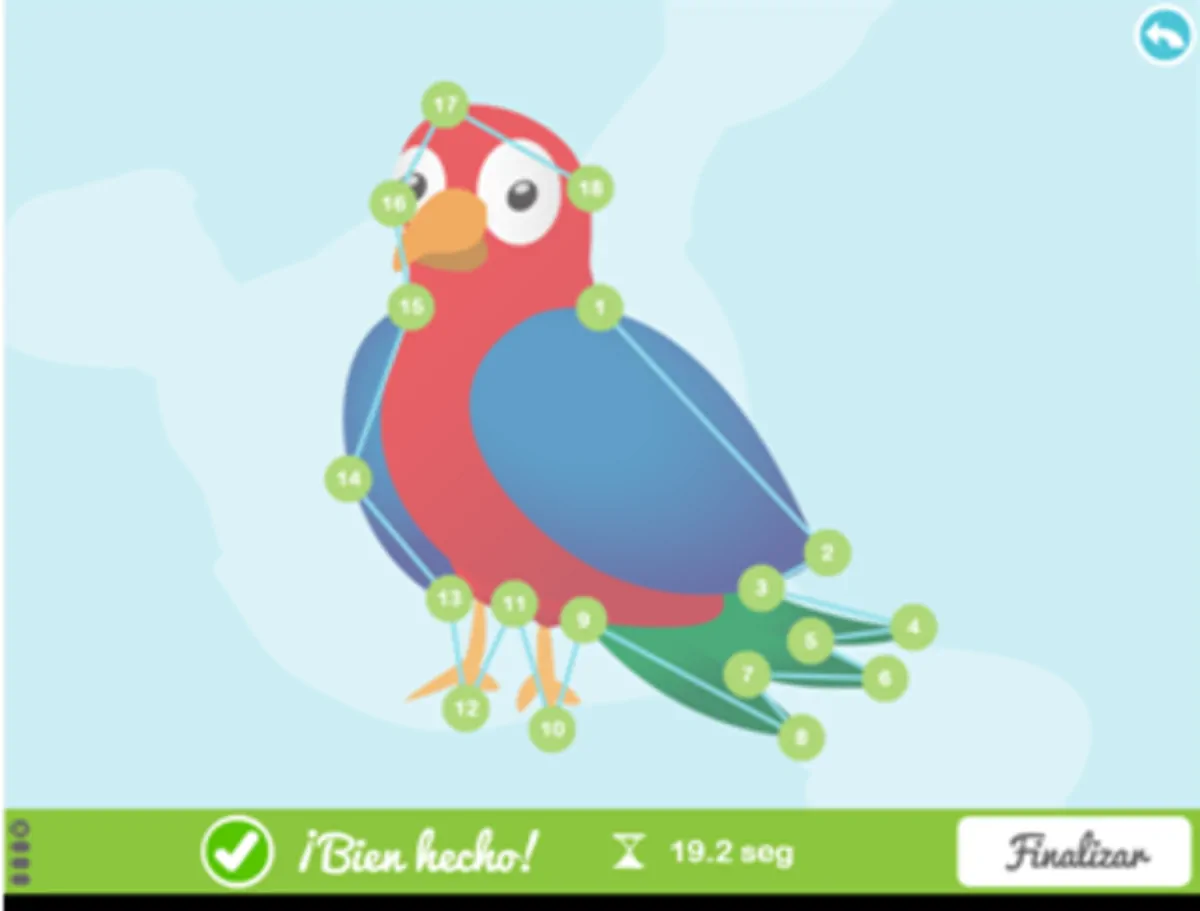
 Riabilitazione dell’attenzione sostenuta
Riabilitazione dell’attenzione sostenuta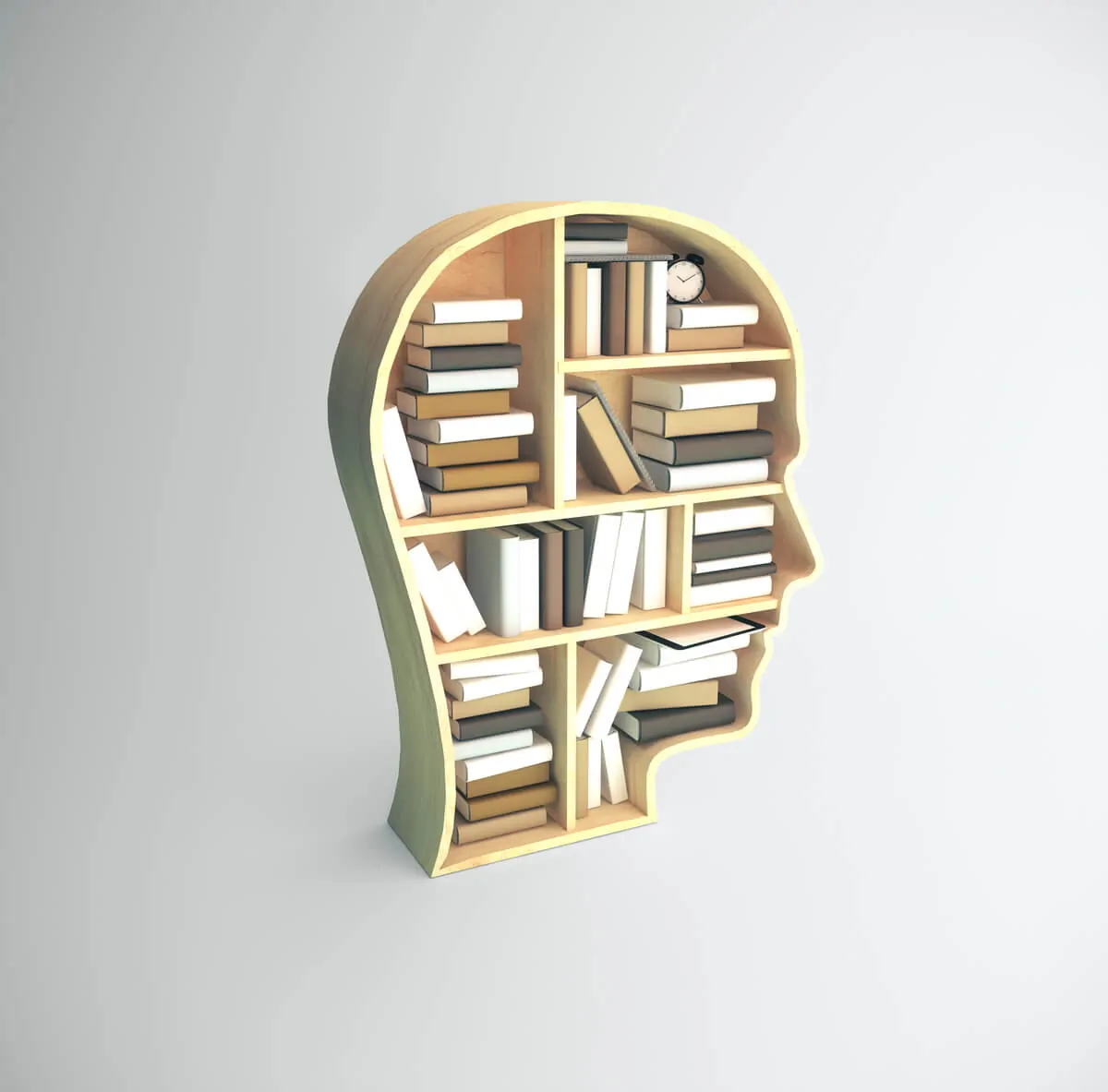

Lascia un commento