Lidia García, neuropsicologa clinica e ricercatrice, spiega in questo articolo che cos’è il fenomeno della confabulazione, nonché la sua classificazione, neuropatologia e meccanismi cognitivi.
Introduzione
Le confabulazioni sono un fenomeno cognitivo che compare in diversi disturbi neurologici acquisiti, ma anche in alcuni disturbi psichiatrici.
Anche se attualmente il termine confabulazione è talvolta utilizzato per riferirsi a percezioni corporee o del mondo esterno false (confabulazioni non mnesiche), tradizionalmente si riferisce a falsi prodotti della memoria (confabulazioni mnesiche)[1].
Si tratta di un fenomeno complesso, per il quale non esiste ancora una definizione consensuale né criteri solidi di classificazione dei diversi tipi descritti e i cui modelli esplicativi sono ancora oggetto di dibattito [1, 2].
Questo articolo rappresenta il primo volume di una serie di due pubblicazioni sul fenomeno della confabulazione, in cui verranno brevemente esaminate la fenomenologia, la neuropatologia e i meccanismi cognitivi e i modelli teorici proposti per spiegarlo. Quest’ultimo punto sarà trattato nel secondo volume della serie.
Cosa intendiamo per confabulazione: concetto e classificazioni
Da quando il termine comparve per la prima volta nei lavori di Kahlbaum [3] e Wernicke [4] verso la seconda metà del XIX secolo, sono state numerose le definizioni e interpretazioni della confabulazione, che ha continuato a evolversi con il dibattito sulla sua eziologia e altri fenomeni cognitivi strettamente correlati [2].
In generale, in letteratura sono stati considerati tre concetti di confabulazione, a seconda degli aspetti ritenuti primari:
- Il mnemonico, legato alla memoria.
- Il linguistico, in cui l’elemento centrale è l’enunciato verbale errato o la narrazione falsa.
- Il epistemologico, in cui l’essenziale è che il paziente non mette in discussione l’affermazione infondata su qualcosa, e questa non è necessariamente di natura linguistica [1].
Una definizione operativa delle confabulazioni proposta di recente [5] le descrive come i falsi ricordi conseguenti a un problema di recupero, dei quali il paziente non è consapevole e la cui convinzione nella veridicità del ricordo è genuina. Da questa concezione le confabulazioni si caratterizzano per quattro aspetti:
- Costituiscono falsi ricordi nel contesto del recupero, che spesso contengono anche dettagli falsi nel proprio contesto (possono consistere in ricordi reali collocati erroneamente nel tempo o non basati su alcuna realtà).
- Non sono prodotti intenzionalmente, poiché il paziente non è consapevole di confabulare e spesso non è nemmeno consapevole di avere un deficit di memoria, il che suggerisce che probabilmente non risultino da meccanismi compensatori.
- I pazienti possono agire coerentemente con le loro confabulazioni, riflettendo una convinzione genuina nel falso ricordo.
- Le confabulazioni si manifestano in modo più evidente quando viene richiesta una raccolta autobiografica e, in determinate condizioni di valutazione, possono comparire anche in compiti di memoria semantica [1].
Classificazioni delle confabulazioni
Per quanto riguarda la loro classificazione in diversi tipi, anche in questo caso sono state proposte varie suddivisioni. Una classificazione ampiamente accettata attualmente è quella proposta da Kopelman [6], che distingue le confabulazioni in base al modo in cui insorgono, suddividendole in confabulazioni spontanee e confabulazioni provocate.
- Le confabulazioni spontanee si caratterizzano per essere poco frequenti ed essere associate a una sindrome amnesica, con disfunzione frontale sovrapposta.
- Le confabulazioni provocate si osservano frequentemente in pazienti amnesici durante la valutazione, quando vengono somministrati test di memoria.
Un’altra classificazione popolare in letteratura le distingue in confabulazioni momentanee e fantastiche [1].
- Le confabulazioni momentanee sono descritte come brevi, di natura transitoria, provocate “invariabilmente” da domande che mettono alla prova la memoria e consistenti in ricordi reali spostati nel contesto temporale.
- Le confabulazioni fantastiche compaiono in modo spontaneo, sono salde, di tematiche varie e generalmente grandiose, molto evidenti nella conversazione quotidiana dei pazienti.
Neuropatologia delle confabulazioni
Esiste una grande varietà di disturbi in cui si manifestano confabulazioni; disturbi sia di carattere acquisito (ad esempio: ictus cerebrale, traumatismo cranioencefalico, ipossia con arresto cardiopolmonare, ecc.) sia degenerativo (demenza), o persino in condizioni psichiatriche come la schizofrenia e altre psicosi. Tuttavia, i due disturbi prototipici in cui si osservano sono la sindrome di Korsakoff e l’emorragia da rottura dell’arteria comunicante anteriore (ACoA) [1].
Nel caso della neuropatologia della sindrome di Korsakoff è stato proposto che esistano due sistemi disfunzionali: uno composto dalla lesione dei corpi mammillari e dei nuclei anteriori del talamo, che riceve afferenze dall’ippocampo attraverso il fornice e che sarebbe correlato all’amnesia severa caratteristica del disturbo; e un altro sistema disfunzionale composto dalla compromissione dei nuclei dorsomediali del talamo, che mantiene connessioni ricorrenti con le aree mediali e orbitofrontali della corteccia prefrontale, riceve afferenze corticali e sottocorticali (amigdala e prosencefalo basale) ed è correlato alla produzione di confabulazioni [1].
Nel caso della patologia da emorragia da ACoA, studi su pazienti con quadro amnesico e presenza di confabulazioni hanno evidenziato lesioni nel prosencefalo basale, nella corteccia prefrontale orbitofrontale e mediale [1].
Una recente revisione [1] conclude che per la comparsa di confabulazioni è necessaria la lesione simultanea delle aree ventro-mediali e orbitofrontali della corteccia prefrontale, mentre un’altra rassegna, che affronta più specificamente le confabulazioni spontanee [2], indica che le evidenze attuali individuano quattro aree implicate in questo tipo di confabulazioni: la corteccia frontale orbito-mediale e le sue connessioni con l’amigdala, il giro cingolato, il nucleo dorsomediale del talamo e l’ipotalamo mediale.
Meccanismi cognitivi delle confabulazioni
In sintesi sono stati proposti tre meccanismi cognitivi per spiegare il fenomeno delle confabulazioni, che differiscono fondamentalmente tra loro nel grado di coinvolgimento del deterioramento della memoria:
- Una disfunzione della memoria in modo primario o centrale, come considerato classicamente.
- Una disfunzione primaria delle funzioni esecutive, considerate condizioni necessarie e sufficienti per la comparsa di confabulazioni.
- Ipotesi duale: una combinazione di deterioramento della memoria e disfunzione esecutiva.
Attualmente, sembra che l’evidenza si orienti verso l’ipotesi duale [1], secondo cui le confabulazioni non sarebbero il risultato di un meccanismo compensatorio dovuto a un problema primario di deficit di memoria o amnesia, bensì conseguenza di un certo grado di alterazione nei sistemi di memoria e di un certo grado di disfunzione nei processi esecutivi.
Tuttavia, resta da chiarire quale sia il contributo specifico dei deficit di memoria e quale quello delle funzioni esecutive nella produzione delle confabulazioni e in quale tipo di confabulazioni.
Una questione da sottolineare è che i diversi studi in merito hanno utilizzato prove di memoria e di funzioni esecutive differenti, che valutano processi esecutivi diversi e sottosistemi di memoria differenti, il che rende praticamente impossibile confrontare i risultati dei diversi studi per trarre conclusioni.
Bibliografia
- Lorente-Rovira E, Berrios G, McKenna P, Moro-Ipola M e Villagrán-Moreno JM (2011). Confabulazioni I: concetto, classificazione e neuropatologia. Actas EspPsiquiatr, 39(4):251-9.
- Glowinski R, Payman V & Frencham, K. (2008). Confabulation: a spontaneous and fantastic review. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 42:932-940.
- Kahlbaum K (1863). Die Gruppierung der psychischen Krankheiten und die Einteilung der Seelenstörungen. Danzig: AW Kafemann (Part III, trans. Berrios GE, Hist. Psychiatry 1996;7:167-181.)
- Wernicke K(1906). Grundriss der Psychiatrie, 2nd edn. Leipzig: Thieme.
- Gilboa A, Alain C, Stuss DT, Melo B, Miller S, Moscovitch M. (2006). Mechanisms of spontaneous confabulations: a strategic retrieval account. Brain, 129:1399-414.
- Kopelman MD (1987). Two types of confabulation. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 50:1482-7.

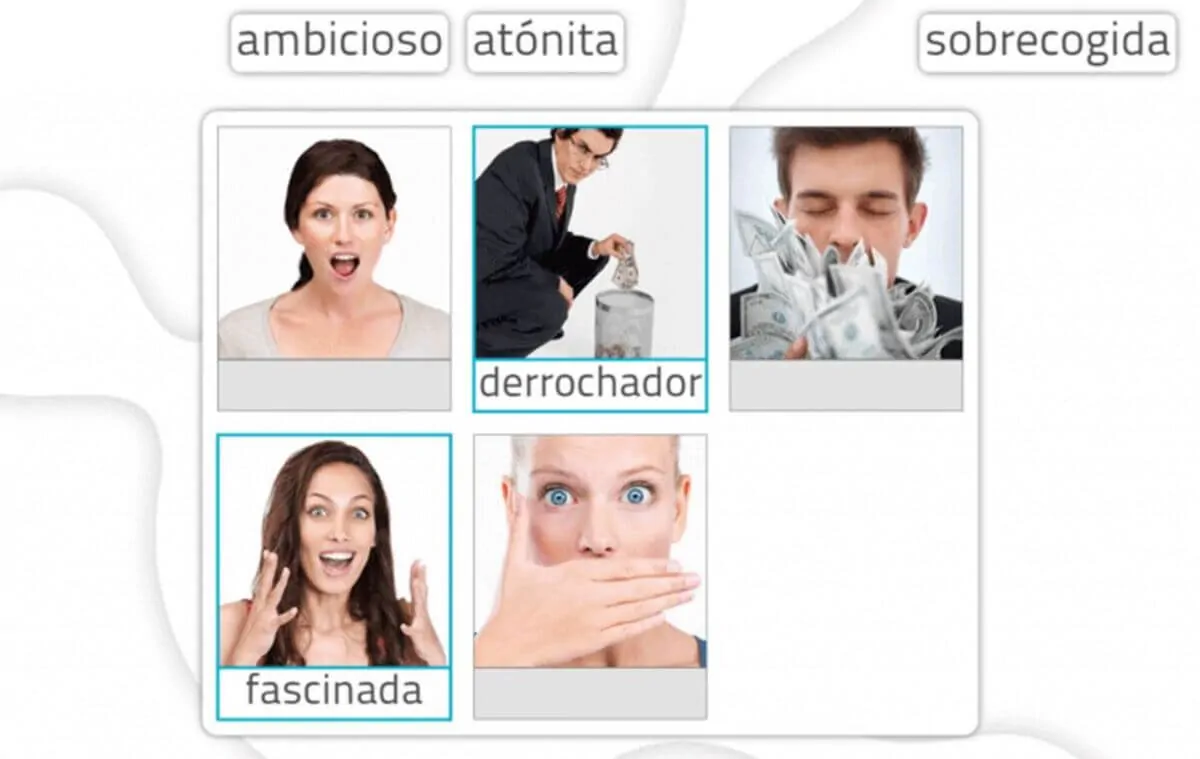




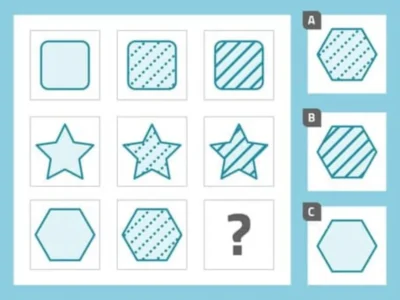
 Allenamento Cognitivo-Motorio: Integrazione di Compiti Duali, Realtà Virtuale e Aumentata
Allenamento Cognitivo-Motorio: Integrazione di Compiti Duali, Realtà Virtuale e Aumentata

Lascia un commento