Il neuropsicologo clinico David de Noreña risponde ai dubbi sulla sua presentazione Approccio non farmacologico del paziente neurologico agitato tenutasi lo scorso 18 gennaio in NeuronUP Academy.
Dubbi sulla presentazione Approccio non farmacologico del paziente neurologico agitato di David de Noreña
1. Yolanda Higueras: Nel caso di pazienti con disturbi della comprensione del linguaggio, quali strumenti non verbali potremmo utilizzare? Quali sarebbero i più efficaci? Grazie David, super interessante e assolutamente d’accordo con Mafalda!
A livello preventivo (controllo dei precedenti) ci sono molte cose che potremmo fare anche se ci sono alterazioni del linguaggio. Per esempio, stabilire routine che permettano di anticipare al paziente cosa succederà di lì a poco, fornire una stimolazione cognitiva –e sociale– minima, assicurarci che non vi sia dolore, disagio, fame, ecc. che possano condizionare il comportamento.
Ovviamente, le alterazioni del linguaggio (o la sua assenza) renderanno più difficile comunicare le intenzioni quando interveniamo (cioè spiegare le linee guida e il programma di modifica comportamentale) e, inoltre, ridurranno la capacità di autoregolazione da parte del paziente.
2. Beatriz Moreno: Mi viene in mente un caso concreto nella residenza dove lavoro. Cosa fare quando il paziente ha problemi di udito, comprende quello che gli si spiega, non sa esprimere i suoi bisogni e inoltre non partecipa alle attività che aiuterebbero a prevenire queste condotte agitate? Grazie mille, mi è piaciuto moltissimo il webinar!
Come dicevo a un’altra tua collega, a livello preventivo (controllo dei precedenti) ci sono molte cose che potremmo fare anche se ci sono alterazioni del linguaggio o problemi uditivi come quelli che descrivi. Per esempio, stabilire routine che permettano di anticipare al paziente cosa succederà di lì a poco, fornire una stimolazione cognitiva –e sociale– minima, assicurarci che non vi sia dolore, disagio, fame, ecc. che possano condizionare il comportamento.
In un caso come quello che descrivi, inoltre, oltre al controllo dei precedenti, sarebbe importante qualche tipo di programma operante (es.: rinforzo differenziale ogni volta che partecipa, rimane in un luogo prestabilito, ecc.).
3. Abigail Mariscal: Mi interessa conoscere strategie di prevenzione, c’è qualche materiale che posso leggere?
https://consaludmental.org/publicaciones/Apoyoconductualpositivo.pdf
http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3404
4. Verónica Alonso: Come dovremmo agire quando il paziente si sveglia agitato durante la notte?
Come ho sottolineato nella presentazione, sebbene l’approccio vari da caso a caso, c’è qualcosa che dobbiamo cercare di fare con tutti i pazienti, ossia comprendere qual è la causa dell’agitazione (che possano o meno comunicarlo).
Generalmente, l’agitazione notturna è condizionata dalla disorientazione, per cui è molto importante tranquillizzare il paziente e orientarlo su dove si trovi, spiegandogli cosa faremo in seguito, ecc., sempre che si escludano altre cause più “fisiologiche” (es.: dolore, disagio, ecc.).
5. Julen Chato Noriega: Con pazienti di mezza età con disturbi psichiatrici che, all’applicazione dell’estinzione, reagiscono con maggiore intensità, hai qualche consiglio? Grazie!
Quando ci troviamo di fronte a un paziente con comportamenti sfidanti come quello che descrivi, dobbiamo effettuare un buon analisi funzionale per determinare sia i fattori scatenanti abituali (es.: persone, contesti, ecc.) sia i possibili rinforzi del comportamento (es.: risate o attenzione di altri pazienti, rimprovero dell’operatore, ecc.). Solo allora saremo in grado di utilizzare le tecniche più adatte in ciascun caso. L’estinzione, come ho detto nella presentazione, non dovrebbe essere applicata a comportamenti potenzialmente dannosi, che richiederanno altre tecniche operanti (es.: costo della risposta).
6. Carlos Corzo: Buon pomeriggio e grazie per il webinar. Cosa succede quando ci troviamo di fronte a casi cognitivamente più preservati (danno cerebrale più cronico), con maggiore autonomia (vive da solo/a), orientati, ma che soffrono di importanti problemi di disfunzione esecutiva e difficoltà nella regolazione dell’aggressività? Quali linee guida potrebbero essere applicabili o quale altro approccio, al di là di quello farmacologico, potrebbe aiutare?
Come ho detto nella presentazione, gli strumenti principali del neuropsicologo saranno la valutazione cognitiva, da una parte, e l’analisi funzionale, dall’altra. Cioè, dovremo valutare in quali contesti e con quale frequenza si manifesta tale comportamento (es.: con quali persone, in risposta a quali richieste) e quali fattori possono mantenerlo (es.: si smette di chiedergli cose che non gradisce, ottiene attenzione sociale, ecc.).
L’approccio sarà, naturalmente, comportamentale, ma in un caso come quello che descrivi dovremmo anche essere in grado di combinarlo, con un allenamento in tecniche per regolare l’irritabilità (es.: tecniche di rilassamento) e lavorare sulla consapevolezza delle difficoltà e sulle implicazioni dei comportamenti con il paziente stesso, per aumentare la sua collaborazione.
Di seguito, ti condivido un link a un manuale abbastanza accessibile che può darti qualche indicazione su come affrontare determinati problemi cognitivi e comportamentali: http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3404
7. Daira García: Buon pomeriggio, grazie per la presentazione. La mia domanda è la seguente: ritiene che alcune delle attività che ha menzionato, come esporsi alla luce del sole o camminare, siano (in alcune occasioni) più benefiche di un trattamento farmacologico? Oppure sarebbero piuttosto un’alternativa preventiva?
È una buona domanda, che ha una risposta difficile. Il mio approccio è che dipenderà da ogni singolo caso. In linea generale, tuttavia, penso che sia etico iniziare con tecniche o procedure meno invasive come quelle comportamentali e, quando queste non sono sufficienti, l’approccio farmacologico aiuterà.
8. Verónica Sánchez: Come agire in un attacco di panico? E come aiutare a contenere i sintomi d’ansia?
La risposta più onesta è che dipenderà dalla situazione cognitiva di ciascun paziente. Di fronte a un attacco di panico, innanzitutto dobbiamo evitare che il paziente si faccia male o aumenti ulteriormente la sua ansia, e questo comporta solitamente restare con lui, cercare di tranquillizzarlo e guidarlo con gentilezza affinché riduca in quel momento la sua agitazione. Per esempio, chiedergli di respirare lentamente, dargli un bicchiere d’acqua, permettergli di muoversi un po’, ecc.
Per quanto riguarda l’ansia, ci sono molte tecniche che possiamo insegnare al paziente, dalla respirazione addominale al rilassamento progressivo, passando per altre legate al mindfulness. Tuttavia, come ti dicevo, dipenderà da ogni paziente e dalla sua situazione cognitiva.
9. Nastra Ares: Molto interessante tutto quello che hai spiegato. Hai parlato di attività fisica quotidiana per la prevenzione dell’agitazione. Ci sono anche attività cognitive?
Certamente, stimolare il paziente con attività cognitive o con momenti di interazione con altre persone migliorerà la sua soddisfazione e partecipazione e, pertanto, contribuirà a ridurre i comportamenti problematici.
È vero che l’attività fisica, che può essere eseguita anche con pazienti molto deteriorati, incorpora un componente insostituibile che implica generalmente una riduzione della tensione interna ed è, pertanto, molto utile nei pazienti che mostrano inquietudine psicomotoria o tendono a vagare o ad auto-stimolarsi con movimenti stereotipati.


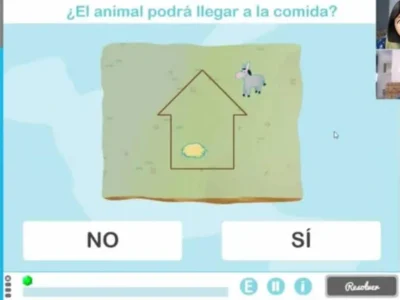

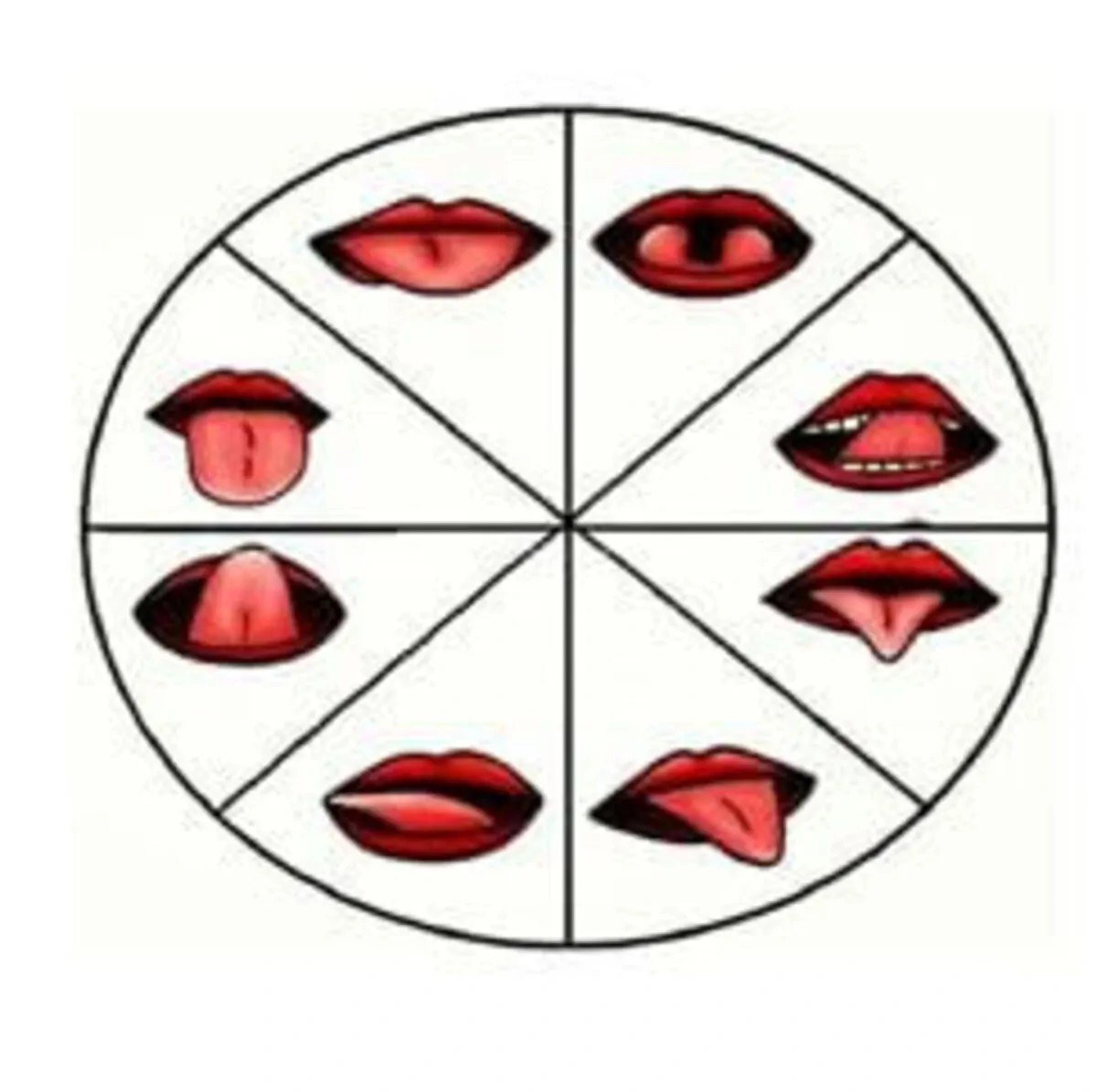



 La logopedia e i disturbi del linguaggio nel Parkinson
La logopedia e i disturbi del linguaggio nel Parkinson

Lascia un commento