La dottoressa in Psicologia Clinica della Salute María J. García-Rubio, insieme alla specialista in neuropsicologia clinica e disturbo cognitivo maggiore Nancy Navarro, spiegano in questo articolo che cos’è la demenza e l’applicabilità clinica della scala GDS.
In questo articolo di divulgazione si intende descrivere la demenza da una prospettiva neuroanatomica e psicobiologica per poi poter giustificare l’applicazione della Scala GDS durante la valutazione neuropsicologica del paziente con diagnosi di demenza.
Anche se si tratta di una scala validata e utilizzata frequentemente dai professionisti neuropsicologi e anche da altri operatori sanitari, è necessario che sia definita e adeguata alla diagnosi per poter estrarre il massimo del suo valore valutativo.
Che cos’è la demenza?
La demenza è un termine generale che identifica le condizioni il cui insieme di segni e sintomi si caratterizza per una progressiva diminuzione della capacità mentale ed esecutiva dei domini cognitivi.
Questa malattia neurologica riduce il grado di autonomia e indipendenza delle persone che ne sono affette, influenzando così la loro capacità di svolgere attività strumentali della vita quotidiana e, di conseguenza, il paziente solitamente richiede un supporto continuativo da parte del proprio caregiver (Alzheimer’s Association, 2014).
Da una prospettiva psicobiologica, le cellule nervose o neuroni sono le prime interessate durante il decorso evolutivo della demenza, sebbene il marcatore chiave sia la presenza dei grovigli neurofibrillari, oltre alla formazione di placche senili osservate nella demenza di tipo corticale (Goriely et al., 2020).
Inoltre, è stato dimostrato che la presenza di microinfarti cerebrali incide negativamente sull’area sottocorticale dell’encefalo, il che nella maggior parte dei casi comporta la comparsa di una demenza vascolare (Bir et al., 2021).
Di conseguenza, ciò provoca una distruzione massiccia dei neuroni della corteccia cerebrale, che finisce per modificare la loro struttura e funzione.
Su un piano neuroanatomico, lo sviluppo di una demenza comporta un processo patologico anatomico del cervello in cui, come fattore comune a tutti i tipi di demenza, si diffondono i poli temporali, con danni anche nella sostanza grigia della neocorteccia parietale e prefrontale, nel caso della Malattia di Alzheimer e della Malattia Frontotemporale (Kang et al., 2019).
Altre patologie neurologiche, come la demenza a corpi di Lewy, presentano un danno neuronale maggiormente localizzato nelle regioni troncoencefaliche (Rodríguez, 2020).
Com’è la valutazione neuropsicologica della demenza?
La demenza è stata al centro di numerose ricerche, con l’obiettivo di conoscerne la fisiopatologia e le conseguenze fisiche e cognitive nella maggior parte dei casi. Successivamente, i gruppi e le linee di ricerca si sono interessati non tanto al concetto, quanto alla sua valutazione e trattamento.
Il numero di casi di demenza aumentava, pertanto doveva esserci almeno uno strumento di valutazione neuropsicologica che completasse il protocollo medico dedicato all’approccio del paziente con demenza.
Per questo motivo, nel 1982 Barry Reisberg e collaboratori hanno pubblicato uno strumento di valutazione attualmente noto come “Scala Globale di Deterioramento o GDS”.
Che cos’è la scala GDS?
Questo strumento ha l’obiettivo di offrire un’alternativa di misurazione neuropsicologica per ogni fase neurodegenerativa legata alla demenza.
Di conseguenza, vengono considerate la capacità cognitiva in senso specifico, la funzione esecutiva, i processi attentivi e della memoria, dall’insorgenza delle prime manifestazioni di deterioramento cognitivo fino alla sua fase finale (Custodio et al., 2017).
A sua volta, la scala GDS considera i confini di ciascuna fase evolutiva della demenza, che si susseguono come un processo lento e continuo. Con queste caratteristiche, la scala GDS mira a offrire un supporto orientativo ai professionisti, neuropsicologi o altri operatori sanitari che lavorano con pazienti con diagnosi di demenza.
Secondo Reisberg et al. (1999), il concetto di retrogenesi è una base fondamentale per l’elaborazione della scala, poiché spiega come il decorso della demenza sia accompagnato da una riduzione della capacità cognitiva.
Inoltre, il decremento nella cognizione è esattamente inverso al processo di acquisizione dell’apprendimento che si realizza dall’infanzia all’età adulta, riflettendosi non solo nei processi cognitivi superiori, ma anche nello sviluppo cerebrale (Strikwerda-Brown et al., 2019).
Per esempio, è possibile che la persona con diagnosi di demenza perda inizialmente le informazioni provenienti dalla memoria a breve termine; nelle fasi intermedie avrà difficoltà ad accedere ai ricordi a lungo termine; mentre nelle fasi finali sarà incapace di controllare processi fisiologici acquisiti nella prima infanzia, come l’autonomia nell’alimentazione o il controllo degli sfinteri.
Fasi della scala GDS
La versione originale della scala GDS di Reisberg et al. (1982) include 7 fasi legate allo sviluppo della demenza. In questo modo, ciascuna di esse descrive l’alterazione corrispondente al decorso fisico, cognitivo e mentale della malattia.
Inoltre, la descrizione dello stato cognitivo per fase è accompagnata da una valutazione approssimativa nel minimental (MEC) di Lobo et al. (1999), al fine di poter collegare entrambi gli strumenti nello stesso paziente. Di seguito, viene presentato un breve excursus per ciascuna di esse e i relativi punteggi:
- GDS 1. Assenza di deficit cognitivo. In questa fase la persona non mostra deterioramento né soggettivo né oggettivo, il che significa che presenta uno stato cognitivo ottimale. Corrisponde a un punteggio di 30-35 nella valutazione MEC.
- GDS 2. Deficit cognitivo molto lieve. Durante questo periodo la persona manifesta lamentele riguardanti la memoria in relazione allo smarrimento di oggetti o alla dimenticanza di nomi, che di norma passano inosservate nell’ambito familiare, lavorativo e sociale. A sua volta, non si riscontra un deficit cognitivo mediante esame clinico. Corrisponde a un punteggio di 25-30 nella valutazione MEC.
- GDS 3. Deficit cognitivo lieve. Si osservano cambiamenti nell’esecuzione di compiti di tipo occupazionale, lavorativo e sociale come, per esempio: difficoltà semantiche, ridotta capacità di trattenere nuove informazioni o di ricordare persone recentemente conosciute, dimenticanze nell’orientamento spaziale, riduzione della concentrazione. Può essere accompagnato da ansia moderata. Corrisponde a un punteggio di 20-27 nella valutazione MEC.
- GDS 4. Deficit cognitivo moderato. La persona presenta difficoltà nell’esecuzione di compiti relativi alla pianificazione di aspetti quali: finanze, cucina, viaggi, operazioni di calcolo. A sua volta diminuisce l’orientamento nel tempo e nella persona, nei fatti recenti, possibile prosopagnosia e labilità emotiva. Corrisponde a un punteggio di 16-23 nella valutazione MEC.
- GDS 5. Deficit cognitivo moderatamente grave. In questa fase, la persona riduce la capacità esecutiva nelle seguenti attività: scelta dell’abbigliamento, ricordare indirizzi, numeri di telefono, nomi di familiari; tuttavia, riconosce il proprio nome e quello della famiglia più stretta. Corrisponde a un punteggio di 10-19 nella valutazione MEC.
- GDS 6. Deficit cognitivo grave. In questa fase, la persona necessita di supporti per svolgere attività strumentali della vita quotidiana, quali vestirsi, fare il bagno, ricordare i nomi dei familiari più stretti o dei caregiver. Può anche manifestare riduzione della continenza urinaria, cambiamenti di personalità e dell’affettività. Corrisponde a un punteggio di 0-12 nella valutazione MEC.
- GDS 7. Deficit cognitivo molto grave. La persona in questa fase presenta perdita delle capacità verbali e motorie come camminare senza aiuto, sedersi, alzarsi e mantenere la testa eretta. Perdita del sorriso. Necessita di assistenza per l’igiene personale. Si osservano segni neurologici. Corrisponde a un punteggio di 0 nella valutazione MEC.
Applicabilità clinica della scala GDS
Come anticipato, la scala GDS ha la particolarità di completarsi con strumenti di valutazione cognitiva, come il MEC, aumentando il potenziale valutativo di questi strumenti di esplorazione cognitiva in una malattia neurologica complessa come la demenza (Peña-Casanova et al., 2014).
Inoltre, questo potenziale è più rilevante nelle fasi avanzate della demenza in cui esiste un’ampia variabilità individuale tra i pazienti. Per questo è così importante disporre di strumenti come la scala GDS, poiché svolge la funzione di guida del processo evolutivo della demenza per il professionista responsabile del paziente.
In base al deterioramento indicato dalla scala GDS, il professionista può istituire nuove linee guida di intervento adattate alle caratteristiche della fase di demenza del paziente, nonché progettare altre strategie di supporto in base alle esigenze della vita quotidiana, delle cure e del trattamento.
Va inoltre sottolineato che, sebbene l’applicazione della scala GDS sia stata propriamente associata alla malattia di Alzheimer a causa della sua evoluzione progressiva, questo strumento di esplorazione neuropsicologica può essere applicato anche in altri casi, come la malattia a corpi di Lewy o la demenza di tipo vascolare (Sousa et al., 2020).
Conclusioni
La scala GDS ha dimostrato di essere valida e affidabile per la determinazione del processo evolutivo della demenza, soprattutto per la sua capacità di differenziare e descrivere il decorso e il progresso della malattia attraverso osservazioni cliniche. Inoltre, è associata ad altre implicazioni cliniche come il miglioramento della prognosi del paziente a partire da nuovi e personalizzati piani di intervento.
In effetti, i punteggi della scala GDS non servono solo a determinare il grado di deterioramento cognitivo, ma anche a ottimizzare il processo decisionale terapeutico e la scelta farmacologica necessaria per contribuire al miglioramento della qualità della vita di questi pazienti.
Bibliografia
Alzheimer’s Association (2014). 2014 Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimer’s & dementia: the journal of the Alzheimer’s Association, 10(2), e47–e92.
Bir, S. C., Khan, M. W., Javalkar, V., Toledo, E. G., & Kelley, R. E. (2021). Emerging concepts in vascular dementia: a review. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 30(8), 105864.
Custodio, N., Becerra-Becerra, Y., Alva-Diaz, C., Montesinos, R., Lira, D., Herrera-Pérez, E., … & Castro-Suárez, S. (2017). Validación y precisión de la escala de deterioro global (GDS) para establecer severidad de demencia en una población de Lima. Ces Medicina, 31(1), 14-26.
Goriely, A., Kuhl, E., & Bick, C. (2020). Neuronal oscillations on evolving networks: dynamics, damage, degradation, decline, dementia, and death. Physical review letters, 125(12), 128102.
Kang, S. H., Park, Y. H., Lee, D., Kim, J. P., Chin, J., Ahn, Y., … & Seo, S. W. (2019). The cortical neuroanatomy related to specific neuropsychological deficits in Alzheimer’s continuum. Dementia and neurocognitive disorders, 18(3), 77-95.
Lobo, A., Saz, P., Marcos, G., Día, J. L., De La Cámara, C., Ventura, T., … & Aznar, S. (1999). Revalidation and standardization of the cognition mini-exam (first Spanish version of the Mini-Mental Status Examination) in the general geriatric population. Medicina clinica, 112(20), 767-774.
Rodriguez Espinoza, T. F. (2020), Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos del deterioro cognitivo y los síntomas neuropsiquiátricos. Neurologia de la congnición y la conducta, Editorial Medica Panamericana,
Reisberg, B., Franssen, E., Hasan, S. et al. Retrogénesis: mecanismos clínicos, fisiológicos y patológicos en el envejecimiento cerebral, el Alzheimer y otros procesos demenciales. Archivos Europeos de Psiquiatría y Neurociencias Clínicas 249 (Suplemento 3), S28–S36 (1999).
Reisberg, B., Ferris, S. H., de Leon, M. J., & Crook, T. (1982). The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. The American journal of psychiatry, 139(9), 1136–1139.
Sousa, S., Teixeira, L., & Paúl, C. (2020). Assessment of major neurocognitive disorders in primary health care: predictors of individual risk factors. Frontiers in Psychology, 11, 1413.
Strikwerda-Brown, C., Grilli, M. D., Andrews-Hanna, J., & Irish, M. (2019). “All is not lost”—Rethinking the nature of memory and the self in dementia. Ageing Research Reviews, 54, 100932.
Peña-Casanova, J. Gramunt Fombuena, N. & Gich Fullá, J. (2004). Test Neuropsicológicos. Fundamentos para una neuropsicología clínica basada en evidencias. Masson: Barcelona.





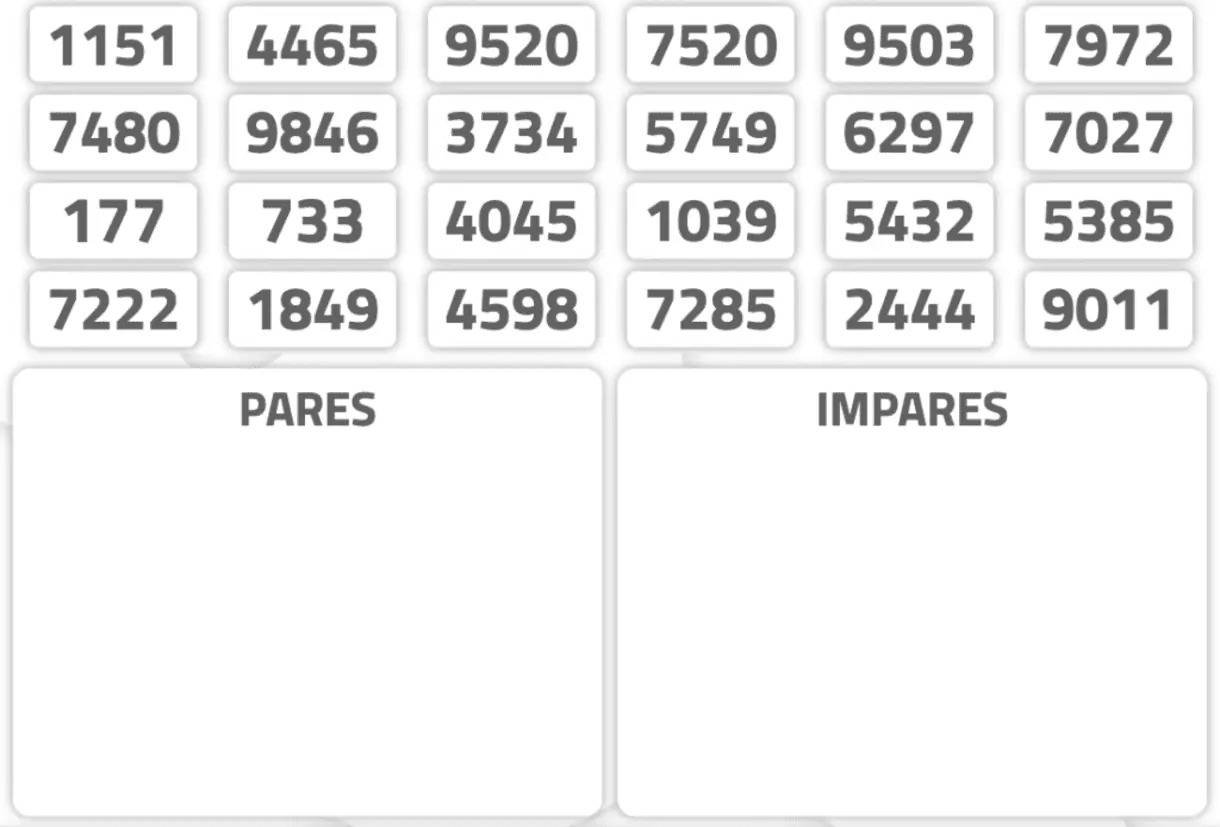
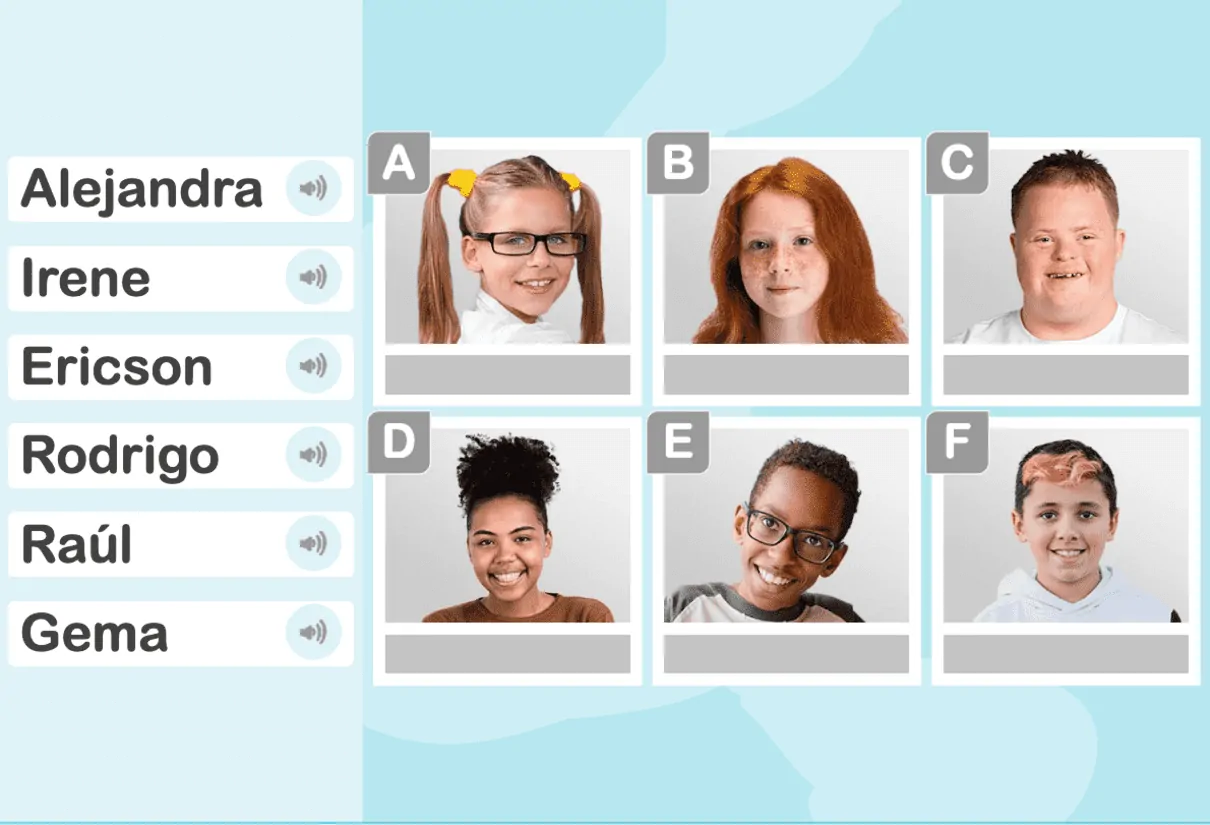


Lascia un commento